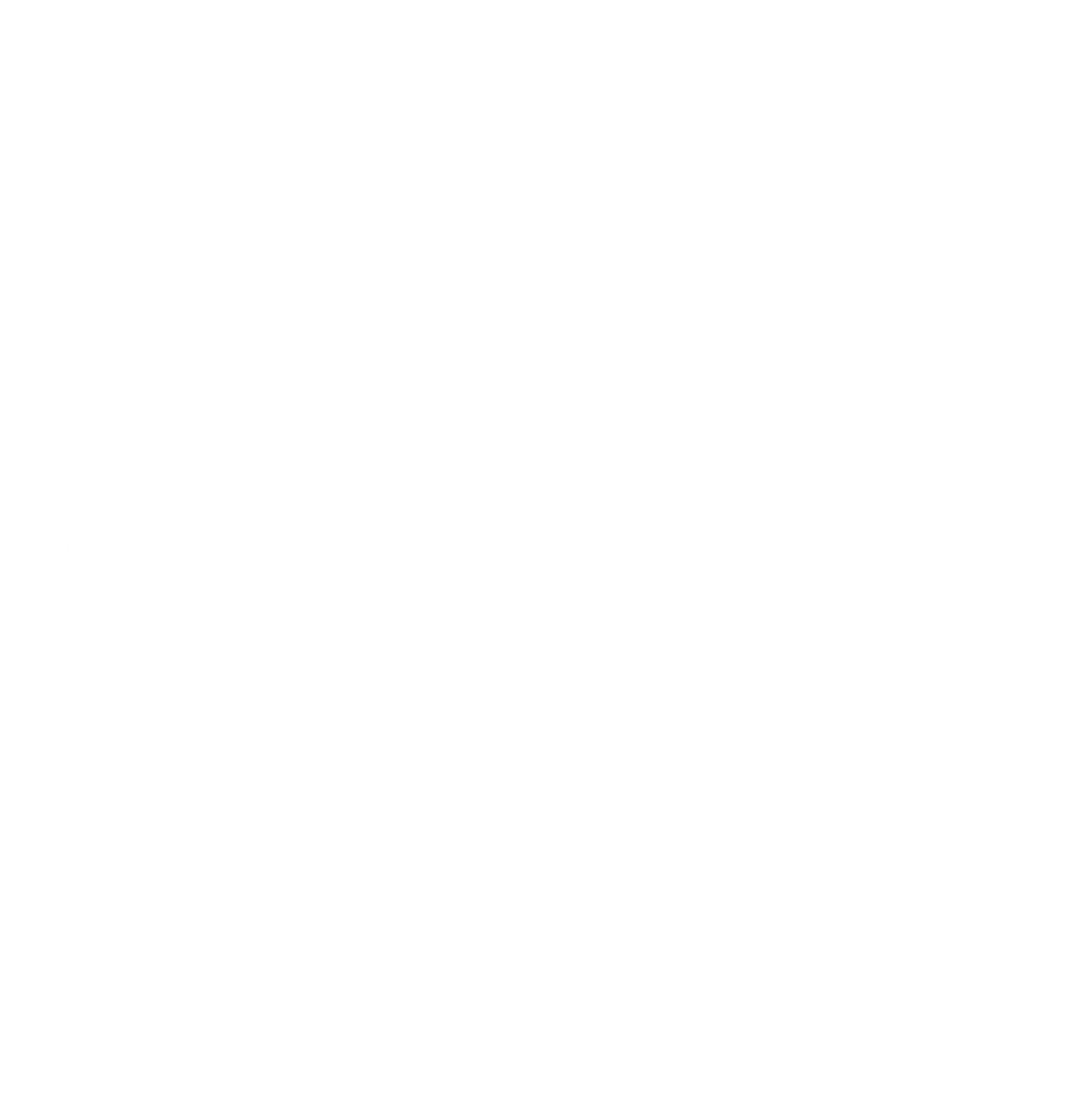Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica
- Information
- Storia del pensiero economico
- Prima pubblicazione: 08 Aprile 2023
«Quando la fede non coincide con la ragione bisogna astenersi dal dare ragione alla fede».
Tommaso d'Aquino
Immaginare un frate domenicano del XIII secolo come figura centrale nella storia del pensiero economico può sembrare strano: eppure, Tommaso d'Aquino occupa un posto di rilievo anche in questo ambito.
Visse in un’Europa attraversata da profondi cambiamenti: la rinascita delle città, la crescita dei commerci e l’emergere di una nuova classe mercantile davano vita a realtà economiche sempre più complesse, sollevando interrogativi morali che, pur avendo radici antiche, si presentavano ora in forme nuove e più articolate.
Le tradizionali certezze di un’economia agraria e feudale non bastavano più a orientare i comportamenti individuali.
A questa trasformazione sociale si accompagnò una rivoluzione intellettuale: la riscoperta del pensiero di Aristotele, che offriva un sistema di conoscenza fondato sulla ragione e sull’osservazione del mondo naturale, spesso percepito in contrasto con la tradizione teologica cristiana.
L’opera di Tommaso d’Aquino si inserisce proprio in questo crocevia tra fede, ragione e mutamenti socio-economici.
Nella sua monumentale opera Summa Theologiae, Tommaso non si limita a commentare le Scritture, ma realizza una sintesi audace tra filosofia aristotelica e teologia cristiana, applicandola a ogni aspetto della vita umana, compresa l’economia.
L’attività economica, per lui, è una branca dell’etica: le azioni economiche devono essere orientate alla giustizia e al bene comune.
In questo articolo, esamineremo le sue idee fondamentali su temi come il diritto di proprietà, il concetto di “prezzo equo” e la questione dell’usura, mostrando come il pensiero di Tommaso abbia posto le basi della dottrina sociale della Chiesa e continui ancora oggi a offrire una prospettiva etica sull’economia.
Indice
- La rinascita economica e intellettuale nel XII e XIII secolo. La riscoperta di Aristotele
- Le posizioni fondamentali di Tommaso d'Aquino
- La dottrina economica di Tommaso d'Aquino
- Considerazioni finali
1. La rinascita economica e intellettuale nel XII e XIII secolo. La riscoperta di Aristotele

«Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno».
Pablo Neruda
Durante la formazione del sistema feudale in Occidente, tra il VII e il X secolo, il commercio nel Mediterraneo era controllato dai grandi stati islamici fondati dai successori di Maometto (570-632).
Tuttavia, nell’XI secolo le invasioni turche in Asia Minore interruppero lo sviluppo della civiltà musulmana e il commercio riprese a fiorire nelle città italiane di Venezia e Genova, che divennero importanti potenze marittime e centri commerciali.
Anche l’argento divenne un bene di scambio molto importante e il prestito a interesse divenne comune, nonostante i divieti della Chiesa. Inoltre, si aprirono mercati per i prodotti agricoli e la vita intellettuale riprese a fiorire, alimentata dalla nascita delle prime università, come quelle di Bologna e Parigi, che divennero fucine di un nuovo sapere.
La riscoperta delle opere di Aristotele, conservate e tradotte presso gli arabi diede un impulso decisivo a questo sviluppo culturale e filosofico.
Aristotele e i suoi commentatori arabi, Avicenna e Averroè, affrontarono i problemi politici cercando di basarsi su principi razionali o scientifici. Il loro approccio mirava a definire la natura dello Stato e di trarne le logiche conseguenze attraverso l'osservazione e la logica.
Al contrario, la tradizione della Chiesa, fortemente influenzata dal pensiero di Sant'Agostino, considerava le questioni politiche e terrene solo in relazione alla salvezza delle anime, creando un profondo conflitto tra i due punti di vista: da un lato la ragione e la filosofia, dall'altro la fede e la teologia.
2. Le posizioni fondamentali di Tommaso d'Aquino

«Una cosa è pensare di essere sulla strada giusta, ma tutt’altra è credere che la tua strada sia l’unica».
Paulo Coelho
Tommaso d’Aquino (1225-1274) propose una visione rivoluzionaria e sintetica, distanziandosi in parte da quella di Agostino sulla vita morale e politica.
La Summa Theologiae, rappresenta il tentativo di creare un sistema organico e coerente in cui fede e ragione potessero coesistere e collaborare armoniosamente.
Secondo Tommaso, l’uomo deve seguire la sua natura, come suggerisce Aristotele. Nella sua vita privata, deve praticare le virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) che possono essere comprese e coltivate attraverso la ragione: questo percorso naturale conduce l'uomo verso la sua realizzazione terrena.
Ciononostante, il suo obiettivo finale e ultimo non è la felicità terrena, ma la contemplazione di Dio nella vita futura, la visione beatifica.
Tommaso sostiene che la vita soprannaturale, resa possibile dalla grazia divina, debba essere considerata superiore alla vita naturale, portandola a compimento e perfezionandola.
Tommaso prende le distanze da Agostino, il quale credeva invece che la religione e la filosofia fossero sullo stesso piano e che il fine della filosofia fosse la ricerca della felicità, ovvero di Dio.
Per Agostino, la filosofia era essenzialmente uno strumento al servizio della fede (credo ut intelligam, credo per capire).
Secondo lui, il male non è un principio negativo ma solo una privazione, un’assenza di bene. Agostino credeva che le virtù cristiane della fede, speranza e carità, fossero condizioni necessarie per il buon esercizio del potere politico, considerando lo Stato come un "rimedio al peccato" (remedium peccati).
3. La dottrina economica di Tommaso d'Aquino

«Nessun uomo dovrebbe vendere una cosa a un altro uomo per più del suo valore».
Tommaso d'Aquino
Nella Summa Theologiae, Tommaso d’Aquino tratta i problemi economici in relazione alle virtù e ai vizi, all’interno di una teoria della condotta morale dell’individuo.
Le sue analisi economiche sono, quindi, inseparabili dalla sua visione etica e teologica.
Egli distingue tra giustizia distributiva e giustizia commutativa:
- La giustizia distributiva riguarda la distribuzione equa dei beni, degli onori e delle risorse all’interno di una società. Questo tipo di giustizia si concentra sulla proporzione e sull’uguaglianza nella distribuzione dei beni tra i membri della società, in base al merito e al ruolo di ciascuno.
- La giustizia commutativa tratta invece dei rapporti tra i singoli individui e si concentra sull’equità negli scambi e nelle transazioni volontarie, come la compravendita. Questo tipo di giustizia si basa sull’idea che gli scambi tra due persone dovrebbero essere equi e che entrambe le parti dovrebbero ricevere un beneficio equivalente, secondo un principio di uguaglianza aritmetica.
In questo senso, la giustizia commutativa assicura un’equivalenza vera tra i benefici reciproci, mentre la giustizia distributiva richiede che i beni siano distribuiti in modo proporzionato all’importanza dei titoli posseduti da ciascun individuo.
Tommaso d’Aquino studia anche i peccati contro la giustizia e identifica tre domande essenziali per l'economia del suo tempo.
La prima questione riguarda la proprietà privata: È lecito, per un uomo, possedere qualcosa di proprio?
A difesa del principio della proprietà privata, riprende le argomentazioni di Aristotele: essa incentiva una migliore cura dei beni, promuove l'ordine sociale e garantisce la pace, poiché ognuno è contento del suo. Tuttavia, Tommaso subordina questo diritto a un principio superiore: la destinazione universale dei beni.
L’uomo non deve possedere beni come se fossero solo suoi, ma come appartenenti a tutti. Ciò significa che deve essere pronto a condividerli con i bisognosi, in caso di necessità.
La proprietà privata, dunque, non è un diritto assoluto, ma uno strumento per il bene comune, e possiede una funzione sociale.
Anche se Aristotele proponeva di moderare un sistema di proprietà e produzione privata con misure che oggi definiremmo socialiste, Tommaso d’Aquino chiede solo ai proprietari terrieri di essere generosi verso i poveri.
Questo concetto sarà ripreso e sviluppato secoli dopo dal magistero della Chiesa. In documenti pontifici come l’enciclica Rerum Novarum del 1891, si preciserà che il dovere dei proprietari di condividere i frutti dei loro beni non è un dovere di giustizia sanzionato dalla legge, ma solo un dovere di carità.
Papa Leone XIII sosterrà, infatti, che la base dell’organizzazione sociale è la proprietà e che l’intervento dello Stato dovrebbe essere eccezionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Papa Giovanni XXIII, nella sua enciclica Mater et Magistra del 1961, manterrà questa posizione, ribadendo la duplice natura, individuale e sociale, della proprietà privata.
La seconda domanda di Tommaso d’Aquino riguarda il commercio: È lecito vendere una cosa per più di quel che vale?
La sua risposta è negativa; in questo senso, Tommaso formula la famosa teoria del “prezzo equo”. Secondo lui, vendere una merce per più di quel che vale o comprarla per meno di quel che vale è ingiusto e illegittimo.
Il "prezzo equo" non era una cifra esatta, ma un valore che doveva riflettere il costo di produzione e garantire il sostentamento del produttore in base alla sua condizione sociale.
Tommaso chiede soprattutto che il venditore non tragga profitto dal particolare bisogno dell’acquirente, sfruttandone la debolezza.
La “teoria del prezzo equo” rimane piuttosto imprecisa sul piano pratico. Tommaso d’Aquino non può seguire completamente la dottrina di Aristotele perché riconosce l’importanza del commercio per l’ascesa della civiltà urbana e mercantile del suo tempo.
Egli mette in evidenza il pericolo del commercio, fonte di avidità e inganno, ma trova Aristotele troppo severo sul piano morale: il commercio può essere legittimo se il suo fine è moralmente valido, come il sostentamento della famiglia, l'aiuto ai poveri o il servizio alla comunità.
In tal modo, Tommaso d’Aquino distrugge una parte essenziale della teoria politica di Aristotele, che vedeva il commercio finalizzato al guadagno come un'attività contro natura, ma non propone una teoria alternativa completa.
La terza domanda di Tommaso d’Aquino riguarda i prestiti a interesse. Nei primi secoli cristiani, i concili ecumenici avevano disapprovato l’usura e l’avevano vietata ai chierici. Nel medioevo, il divieto divenne assoluto e generale.
A prima vista, la posizione di Tommaso d’Aquino sembra semplice e categorica. Egli condanna il prestito a interesse sulla base dell’argomento di Aristotele: il denaro, per sua natura, non si riproduce.
Chiedere un interesse, secondo Tommaso, significava vendere due volte la stessa cosa: il denaro prestato e il tempo del suo utilizzo, che invece appartiene a Dio.
Tuttavia, nell’esaminare la Summa Theologiae, si nota come Tommaso d’Aquino tenda a fare concessioni alle esigenze dei tempi. Queste concessioni sono formulate con grande cautela per impedire la diffusione di pratiche pericolose per le anime.
Egli introduce delle eccezioni basate su titoli estrinseci al prestito: si tratta di concessioni che distruggono il divieto di interesse come tesi politica e costituiscono un primo passo verso l’accettazione di fatto di pratiche moralmente condannate.
Si apre così una breccia che annullerà, in pratica, la condanna dell’usura. Il creditore poteva infatti chiedere un risarcimento non per il prestito in sé, ma per il danno subito (damnum emergens) o per il mancato guadagno (lucrum cessans) derivante dalla privazione del suo denaro.
Il lucrum cessans dovrà essere compensato dagli interessi.
4. Considerazioni finali
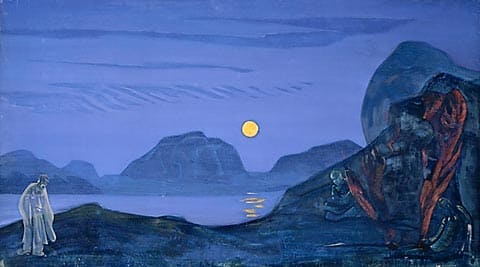
«La gente non ama pensare. Se uno pensa, deve poi giungere a delle conclusioni. Le conclusioni non sempre sono piacevoli».
Helen Keller
Tommaso d’Aquino è stato uno dei pilastri del pensiero cristiano e ha dato un contributo indiscusso alla materia economica, analizzando il ruolo della proprietà privata, la teoria della giustizia, gli aspetti etici del commercio, la formazione del giusto prezzo, l'usura e l'interesse.
La filosofia di Tommaso d’Aquino cerca di conciliare la scienza aristotelica e la morale cristiana: la sua è una grandiosa sintesi che crea un ponte tra la rivelazione divina e la razionalità umana, affermando che la grazia non annulla la natura, ma la perfeziona.
Egli vuole essere fedele sia alla scienza di Aristotele, che permette o vieta in base alla ragione, sia alla religione cristiana, che permette o vieta in base alla coscienza del soggetto che agisce in accordo o disaccordo con il modello di Gesù Cristo.
Tommaso d’Aquino si distacca dall’atteggiamento di relativa indifferenza verso le questioni economiche adottato dalla Chiesa del Medioevo sotto l’influenza di Agostino, inserendo l'attività economica in un quadro etico e sociale ben definito.
Nel Rinascimento, la filosofia economica si svilupperà al di fuori del cristianesimo e spesso contro di esso: si assisterà a un’evoluzione del pensiero economico che si allontanerà dalle posizioni della Chiesa per svilupparsi in modo indipendente, ponendo le basi per la moderna scienza economica.
Nonostante questo, il pensiero di Tommaso d'Aquino rimane una pietra miliare, le cui riflessioni sulla giustizia, il bene comune e la dignità del lavoro continuano a influenzare il dibattito etico ed economico contemporaneo.
La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:
1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone
2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone
3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica
4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno
5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti
6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica
7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo
8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito
9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say
10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi
11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero
12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico
13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier
14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero
15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale
16. Karl Marx: La teoria del valore
17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico
18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto
19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista
20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista
21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità
22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher
23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità
24. La Scuola Storica Tedesca di economia
25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale
26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano
27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico
28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta
29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises
32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione
33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità
34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia
35. Piero Sraffa
...