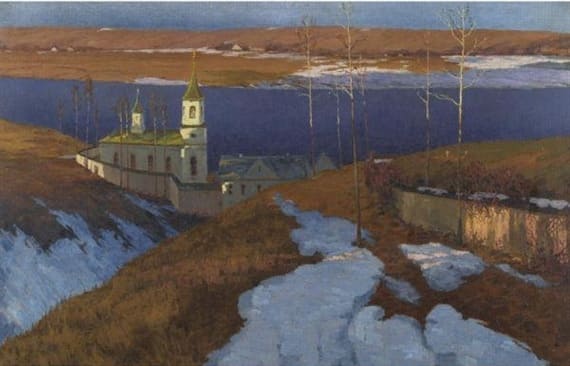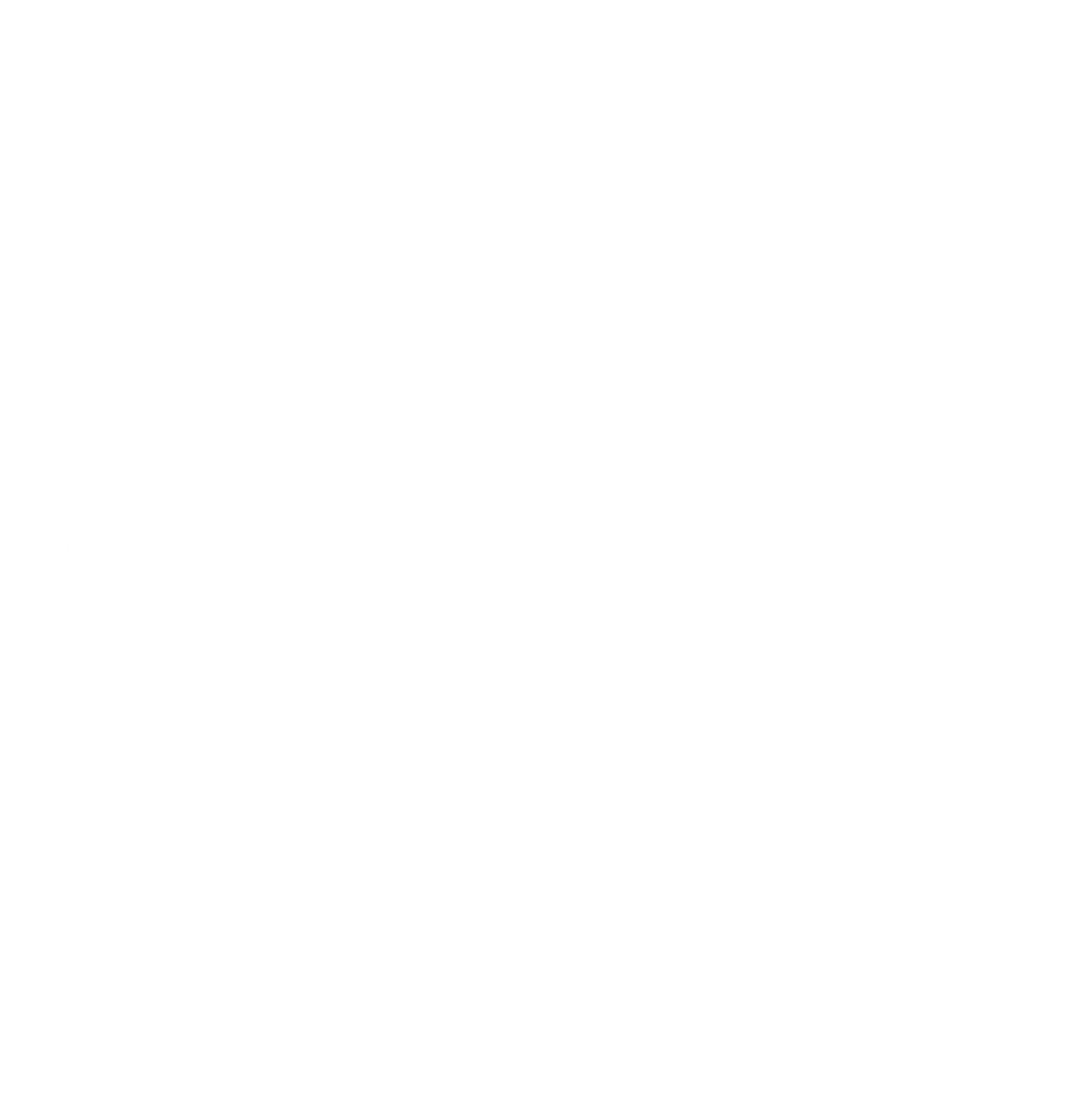La critica all’ortodossia e le basi del pensiero keynesiano
- Information
- Storia del pensiero economico
- Prima pubblicazione: 09 Agosto 2025
«The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty».
John Maynard Keynes
Dopo aver ripercorso, nel primo articolo, il cammino che portò John Maynard Keynes a rompere con l’ortodossia economica, ci concentriamo adesso sull’impianto analitico che elaborò come alternativa.
Una volta superata la critica alla “Scuola Classica”, l’obiettivo diventa quello di esplorare i meccanismi interni della sua rivoluzione teorica.
Analizzeremo i pilastri su cui si fonda la Teoria Generale:
- Il principio della domanda effettiva, che rovescia la logica della Legge di Say.
- Il ruolo non neutrale della moneta, concepita come “ponte verso il futuro” in un contesto segnato dall’incertezza.
- La dinamica del moltiplicatore, che illustra come gli stimoli alla spesa possano produrre effetti amplificati su reddito e occupazione.
Attraverso questi strumenti, Keynes offrì una chiave di lettura radicalmente nuova per comprendere e affrontare le crisi in un’economia di mercato.
Indice
- Le basi del pensiero keynesiano: dalla critica all’ortodossia alla rivoluzione teorica
- Dal Trattato sulla Moneta alla Teoria Generale: l’evoluzione del pensiero keynesiano
- Il metodo di Keynes: tra logica, intuizione e realtà
- Ricezione, sviluppi e attualità del pensiero keynesiano
1. Le basi del pensiero keynesiano: dalla critica all’ortodossia alla rivoluzione teorica
Il punto di partenza della rivoluzione keynesiana è la demolizione di un presupposto centrale dell’ortodossia economica: l’idea che l’economia tenda spontaneamente verso la piena occupazione.
Secondo Keynes, le teorie tramandate da Ricardo fino a Pigou non descrivevano il funzionamento generale del capitalismo, ma solo un caso speciale: una condizione ideale e rara, lontana dalla realtà.
Applicare questa visione a un mondo caratterizzato da disoccupazione persistente e cicli economici ricorrenti rappresentava, a suo avviso, un errore metodologico dalle conseguenze disastrose.
Il cuore della sua critica era rivolto all’idea, radicata nella tradizione ricardiana e nella Legge di Say, secondo la quale l’offerta genererebbe automaticamente la propria domanda.
In altri termini, si presumeva che ogni bene prodotto creasse un reddito sufficiente a garantirne l’acquisto, rendendo impossibili crisi da sovrapproduzione generalizzata.
Per Keynes, questa visione era viziata da un presupposto fondamentale: ignorava il ruolo del risparmio.
Se i consumatori decidono di non spendere tutto il proprio reddito e se il risparmio non viene immediatamente e interamente trasformato in investimenti da parte delle imprese, si apre una falla nel sistema: la domanda aggregata può risultare inferiore all’offerta complessiva, spingendo le imprese a ridurre la produzione e a licenziare i lavoratori.
Malthus aveva già cercato di contrastare Ricardo su questo punto, ma senza riuscire a formulare un’alternativa teorica coerente.
Le idee ricardiane continuarono così a dominare il pensiero economico per oltre un secolo, trasformandosi in un vero e proprio dogma: il “grande enigma della domanda effettiva”, che aveva tormentato Malthus, era stato completamente rimosso dalla letteratura ortodossa.
La critica di Keynes mirava alle implicazioni delle sue premesse. Descriveva la logica classica, una logica bivalente, di stampo aristotelico, come dry bones: un’impalcatura perfetta sul piano formale, ma priva di vita vera, incapace di rappresentare un mondo in cui le decisioni economiche sono prese in condizioni d’incertezza.
Le assunzioni della teoria neoclassica, nella loro pretesa di validità universale, apparivano a Keynes del tutto scollegate dalla realtà del suo tempo.
La critica di Keynes si estende anche all’idea, radicata nella tradizione classica, che l’economia possa essere assimilata a un sistema di baratto o di “scambio reale”, dove il denaro ha un ruolo puramente neutrale, limitato a fungere da mezzo di scambio utile solo a definire i prezzi relativi dei beni.
Al contrario, Keynes sottolinea come il denaro sia un fattore operativo, in grado di influenzare in modo determinante le motivazioni e le decisioni degli agenti economici.
Proprio da questa intuizione nasce la sua teoria monetaria della produzione, basata sull’idea che i principi validi in un’economia di baratto non siano applicabili, in modo automatico, a un’economia monetaria.
La caratteristica distintiva del denaro, secondo Keynes, è che la sua importanza derivi essenzialmente dal suo essere un legame tra il presente e il futuro.
In altri termini, il denaro è uno strumento che consente di rinviare le decisioni di spesa, non un semplice velo che nasconde gli scambi reali: agisce come riserva di valore, offrendo un rifugio di fronte all’incertezza ma, al tempo stesso, può interrompere il flusso circolare del reddito e generare instabilità.
Questa prospettiva apre la strada a un’analisi delle economie capitalistiche più aderente alla realtà, in cui trovano spazio fenomeni come i cicli economici, le crisi e la disoccupazione, con il denaro e i tassi d’interesse a svolgere un ruolo centrale.
In un accostamento suggestivo, Keynes è stato persino definito «il Karl Marx dell’economia neoclassica», per aver cercato, pur con finalità e metodi radicalmente diversi, di superare i limiti dell’economia classica.
2. Dal Trattato sulla Moneta alla Teoria Generale: l’evoluzione del pensiero keynesiano
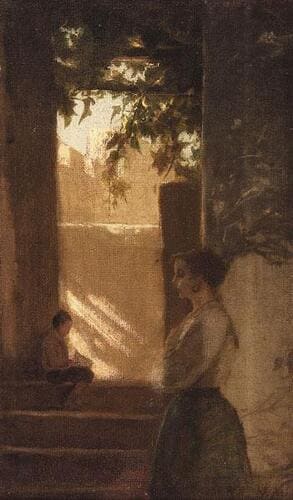
«The workers spend what they get, and capitalists get what they spend».
Michał Kalecki
Il Trattato sulla Moneta, pubblicato nel 1930 dopo oltre sei anni di lavoro, anticipa molte delle idee che sarebbero diventate centrali nella Teoria Generale.
Sebbene l’opera si collochi nella tradizione marshalliana, introduce importanti innovazioni che rappresentano un ponte verso le posizioni più radicali che Keynes adotterà negli anni successivi.
Nel Trattato, Keynes critica la teoria quantitativa della moneta di Irving Fisher, secondo cui l’andamento dei prezzi dipende in modo meccanico dall’offerta di moneta.
Fisher riassumeva il legame in questa celebre identità:
\begin{equation}
M \cdot V = P \cdot T
\end{equation}
M = quantità di moneta in circolazione.
V = velocità di circolazione.
P = livello generale dei prezzi.
T = volume delle transazioni reali (o della produzione).
Se V e T restano fissi, un aumento di M provoca automaticamente un aumento proporzionale di P.
Per Keynes, però, questa visione meccanicistica trascura il motivo per cui le persone detengono o spendono moneta e ignora il fatto che V può collassare nei momenti di incertezza.
A questa impostazione, egli contrappone l’equazione di Cambridge, che sposta il focus dall'offerta alla domanda di moneta.
In questo schema, la quantità di moneta detenuta non è imposta dall’esterno, ma nasce da una scelta comportamentale: gli individui decidono quanta parte del loro reddito mantenere in forma liquida in funzione di esigenze di transazione, di precauzione o di speculazione.
L’equazione, nella notazione comunemente usata, è:
\begin{equation}
M^{d} = k \, P \, Y
\end{equation}
Md = domanda di moneta.
k = quota del reddito che si vuole conservare in moneta (quindi k = 1/V).
P = livello dei prezzi.
Y = reddito reale.
In altre parole, la stessa relazione monetaria può essere letta da due prospettive complementari:
- L’identità di Fisher descrive quante volte la moneta “gira” per finanziare il reddito: se la velocità V è elevata, ogni unità di moneta finanzia molte transazioni.
- L’equazione di Cambridge osserva invece quanta moneta gli individui scelgono di trattenere: questa propensione, indicata con k, cresce quando prevale il desiderio di liquidità e si riduce quando la moneta viene spesa più rapidamente. Poiché in equilibrio l’offerta di moneta deve eguagliare la domanda, un aumento di k implica automaticamente una diminuzione di V: da qui la semplice identità k = 1/V, che collega la rapidità con cui la moneta circola alla quota di reddito mantenuta in forma liquida. Questa prospettiva sposta l’attenzione dalla quantità di moneta al modo in cui le persone effettivamente la utilizzano.
L’opera analizza anche i meccanismi di trasmissione dei tassi d’interesse e il ruolo della banca centrale nella stabilizzazione economica. Per Keynes, quest’ultima non dovrebbe limitarsi a garantire la liquidità del sistema, ma assumere un ruolo attivo nella regolazione della domanda aggregata.
Attraverso il controllo delle riserve bancarie, la banca centrale può influenzare gli investimenti netti modulando i tassi d’interesse.
Inoltre, come “autorità pubblica o monetaria” orientata al benessere collettivo e non al profitto, dovrebbe intervenire direttamente nel mercato dei capitali, anche acquistando titoli pubblici ad alto rischio per stimolare la produzione e correggere le inefficienze del mercato.
Un’idea innovativa, che andava ben oltre la concezione tradizionale del prestatore di ultima istanza, attribuendo alla banca centrale un ruolo proattivo, soprattutto nei momenti in cui l’iniziativa privata è frenata dall’incertezza.
Pur anticipando molte delle future conclusioni politiche di Keynes e evidenziando già un chiaro distacco dalla Legge di Say, il Trattato non fornisce ancora la cornice teorica compiuta che sarà sviluppata nella Teoria Generale.
Un ulteriore aspetto rilevante è l’attenzione riservata ai rapporti monetari internazionali: Keynes non propone un sistema basato sull’oro, ma su una valuta emessa da una banca centrale internazionale, il cui valore venga ancorato a un paniere di beni commerciabili.
Tale approccio riflette la sua preferenza per regole flessibili e discrezionali, in contrapposizione alla rigidità deflazionistica del Gold Standard, che imponeva ai paesi in deficit di comprimere la propria economia, con gravi effetti sull’occupazione.
Sarà con la Teoria Generale del 1936, tuttavia, che Keynes elaborerà in modo sistematico il nucleo della sua rivoluzione teorica, concentrandosi sulla domanda effettiva e sul concetto di moltiplicatore.
Keynes rovesciò la logica della Legge di Say: non è l’offerta a generare la domanda, ma è la domanda, in particolare quella derivante dalla spesa per investimenti, a determinare il livello di produzione e occupazione. Le imprese, infatti, producono solo ciò che si aspettano di riuscire a vendere.
Se la domanda aggregata è debole, perché le imprese, frenate dall’incertezza, non investono e i consumatori, preoccupati, risparmiano, l’economia può stabilizzarsi in un equilibrio di sottoccupazione, duraturo e difficile da superare.
Per uscire da questa trappola è necessario uno stimolo esterno alla domanda, ed è qui che entra in gioco il moltiplicatore: immaginiamo, ad esempio, che lo Stato investa 100 milioni in un progetto infrastrutturale, come la costruzione di un ponte. Questa spesa non si esaurisce nel primo passaggio: diventa reddito per imprese edili, lavoratori e fornitori.
Se questi soggetti hanno una propensione al consumo dell’80% – ovvero spendono 80 centesimi per ogni euro guadagnato – quei 100 milioni genereranno 80 milioni di spesa addizionale. A loro volta, questi 80 milioni diventeranno reddito per altri soggetti economici, che ne spenderanno l’80% (cioè 64 milioni), e così via.
Questo processo a catena prosegue finché l’impatto iniziale si esaurisce gradualmente, ma la somma complessiva del reddito generato sarà un multiplo dell’investimento iniziale.
Nell’esempio, un investimento di 100 milioni può generare un aumento complessivo del reddito pari a 500 milioni: un moltiplicatore pari a 5.
Il moltiplicatore keynesiano dimostra come un intervento esogeno, come la spesa pubblica, possa avere un effetto amplificato sull’intero sistema economico, contribuendo ad aumentare reddito e occupazione in una fase di stagnazione.
3. Il metodo di Keynes: tra logica, intuizione e realtà
L’approccio teorico di Keynes è inseparabile dalla sua visione della scienza economica: egli non considerava l’economia una scienza dura, alla ricerca di leggi universali e immutabili, bensì una branca della logica e al tempo stesso un’arte che richiede la selezione di modelli pertinenti al contesto storico e sociale.
Il rifiuto del formalismo fine a sé stesso e delle regole rigide si traduceva in un metodo flessibile e discrezionale, capace di adattarsi alle contingenze, tanto nella politica monetaria quanto nelle relazioni internazionali.
Il fulcro di questo approccio risiede nella distinzione, già delineata nel Trattato sulla Probabilità, tra rischio calcolabile e incertezza radicale.
Quest’ultima prevale nelle decisioni economiche di lungo periodo, come gli investimenti, dove la conoscenza è inevitabilmente “vaga e scarsa”, e gli agenti sono costretti a fare affidamento su aspettative e fiducia, più che su dati certi.
Da ciò deriva la preferenza di Keynes per il ragionamento induttivo rispetto alla deduzione assiomatica tipica dell’ortodossia: l’analisi economica, secondo lui, deve basarsi su un “grado razionale di credenza”, piuttosto che su certezze astratte e formalizzazioni matematiche.
Come abbiamo visto nel primo articolo su Keynes, questo impianto metodologico trova una delle sue espressioni più chiare nel concetto di fallacia di composizione: un comportamento perfettamente razionale sul piano individuale può condurre a esiti collettivi del tutto irrazionali.
Un caso particolarmente eloquente è il paradosso della parsimonia: mentre il risparmio è vantaggioso per il singolo individuo, un risparmio diffuso e simultaneo, se non accompagnato da un adeguato aumento degli investimenti, può innescare una spirale recessiva.
Mostrando come la somma delle virtù private possa sfociare in un vizio pubblico, Keynes giustificava così l’esigenza di un’analisi propriamente macroeconomica, distinta e autonoma rispetto a quella microeconomica.
4. Ricezione, sviluppi e attualità del pensiero keynesiano
La pubblicazione della Teoria Generale avvenne in un contesto segnato da una profonda crisi economica globale, che creò le condizioni per una più ampia ricezione delle idee keynesiane.
Keynes, figura intellettuale fortemente impegnata anche sul piano politico, partecipò attivamente a dibattiti e conferenze internazionali con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla costruzione di un capitalismo riformato, capace di garantire equità, libertà ed efficienza, soprattutto di fronte alla crescente minaccia dei totalitarismi.
Nonostante il successo e l’impatto dirompente dell’opera, il pensiero di Keynes fu oggetto di numerose reinterpretazioni e critiche.
La sua apertura verso la tradizione marginalista, anche sotto l’influenza dei giovani economisti del Cambridge Circus, lo portò a rivedere alcune posizioni espresse nel Trattato sulla Moneta, aprendo la strada alla cosiddetta sintesi neoclassica.
Questa sintesi, formalizzata nel celebre modello IS-LM elaborato da John Hicks, tradusse il mondo dinamico e incerto delineato da Keynes in un sistema statico di equazioni simultanee: fu una semplificazione che ne facilitò l’integrazione nella teoria economica dominante, ma al prezzo di annacquarne la portata innovativa.
Non a caso, Joan Robinson etichettò ironicamente questa versione attenuata del pensiero keynesiano come quella dei keynesiani bastardi.
Anche sul piano teorico, le critiche non mancarono. Alcuni osservatori gli rimproverarono una certa ambiguità nel trattare i titoli finanziari, trascurando la distinzione tra la loro funzione di attività per chi li acquista e quella di passività per chi li emette.
Altri economisti, come Michal Kalecki, giunsero a conclusioni simili sulla centralità della domanda effettiva e sull’instabilità del capitalismo, ma seguirono un approccio teorico differente, meno incentrato sull’incertezza e sulla finanza, e più focalizzato su aspetti come la formazione dei prezzi attraverso il principio del costo pieno, secondo cui le imprese fissano i prezzi sommando ai costi un margine di profitto stabile.
Di particolare rilievo fu la posizione di Piero Sraffa, la cui critica radicale al marginalismo si fondava su una ripresa del pensiero classico, incentrato sul concetto di surplus.
Sebbene Sraffa abbia influenzato Keynes su alcuni punti, il suo lavoro poneva una sfida profonda alla compatibilità tra keynesianismo e analisi marginalista: secondo Sraffa, qualsiasi tentativo di conciliare i due approcci finiva per risultare privo sia di rigore teorico sia di aderenza alla realtà.
Nonostante queste divergenze e riletture, il contributo di Keynes ha lasciato un’impronta profonda sulla teoria economica, che va ben oltre i confini del dibattito accademico: l’eredità di Keynes consiste in un radicale cambiamento di paradigma impresso all’economia.
Dimostrando che un’economia di mercato può stabilizzarsi in equilibri di sottoccupazione, a causa dell’incertezza e della fallacia di composizione, ha legittimato la macroeconomia come disciplina autonoma e reso intellettualmente necessario il ruolo dello Stato come stabilizzatore del sistema.
La sua “lunga lotta per sfuggire” all’ortodossia ha ridefinito la natura stessa dell’economia: non più una scienza alla ricerca di leggi universali, bensì un’arte diagnostica, che richiede giudizio, flessibilità e un costante confronto con la realtà.
Sebbene il suo pensiero sia stato spesso semplificato o distorto attraverso la sintesi neoclassica, il lascito più autentico di Keynes sopravvive nelle domande che ancora oggi animano il dibattito pubblico.
Le discussioni su spesa pubblica e austerità, sul ruolo delle banche centrali nelle crisi, o sulla necessità di una governance economica internazionale, rappresentano la continuazione di un dialogo iniziato da Keynes stesso: segno che il suo pensiero, inquieto e profondo, resta di straordinaria attualità.
La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:
1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone
2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone
3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica
4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno
5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti
6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica
7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo
8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito
9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say
10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi
11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero
12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico
13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier
14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero
15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale
16. Karl Marx: La teoria del valore
17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico
18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto
19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista
20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista
21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità
22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher
23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità
24. La Scuola Storica Tedesca di economia
25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale
26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano
27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico
28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta
29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises
32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione
33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità
34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia
35. Piero Sraffa
...