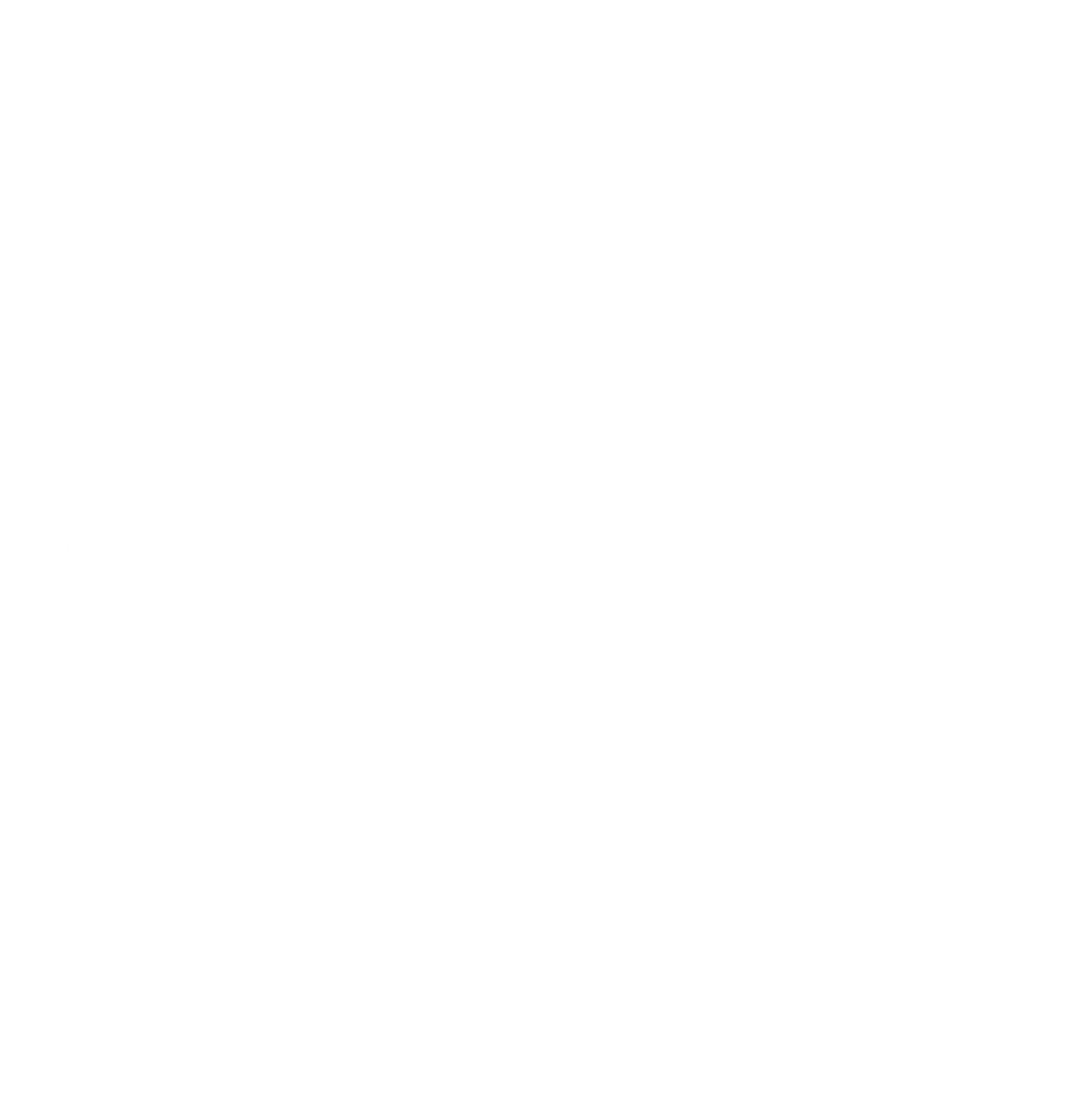La Teoria Generale di John Maynard Keynes: una rivoluzione nel pensiero economico
- Information
- Storia del pensiero economico
- Prima pubblicazione: 24 Agosto 2025
«It is better to be roughly right than precisely wrong».
John Maynard Keynes
La pubblicazione della Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936) da parte di John Maynard Keynes rappresentò un momento di svolta nel panorama economico mondiale.
Il libro, che pose le basi della macroeconomia moderna, fu accolto con un entusiasmo quasi febbrile soprattutto tra i giovani economisti, in cerca di strumenti innovativi per comprendere e affrontare la crisi che dal 1929 stava travolgendo l’intero tessuto economico e sociale.
Indice
- La necessità di una "Teoria Generale"
- Domanda effettiva e disoccupazione
- Incertezza, aspettative e spiriti animali
- Moneta, interesse e paradossi dell’economia aggregata
- Spesa pubblica, investimenti e filosofia sociale
1. La necessità di una "Teoria Generale"
L’obiettivo di Keynes, dichiarato fin dalle prime pagine della Teoria generale, era mettere in discussione la cosiddetta “teoria classica”: un’espressione da lui stesso coniata per includere economisti come Ricardo, J. S. Mill, Marshall, Edgeworth e Pigou.
Keynes spiega che l’espressione “economisti classici” era stata originariamente introdotta da Marx per indicare Ricardo, J. S. Mill e i loro predecessori, considerati i fondatori della teoria che avrebbe poi trovato compimento nell’economia ricardiana.
Keynes ampliò questa etichetta per comprendere anche i successori di Ricardo, che ne avevano sviluppato e perfezionato l’impianto teorico: la sua intenzione era mostrare che i principi di quella scuola descrivevano soltanto un caso speciale, non applicabile alla generalità delle situazioni economiche.
All’inizio della prefazione, Keynes osserva che “Se l’economia ortodossa è in errore, l’errore non risiede nella sua sovrastruttura, costruita con grande attenzione alla coerenza logica, ma nella scarsa chiarezza e nella limitata generalità delle premesse”.
Secondo Keynes, la realtà economica successiva alla crisi del 1929 richiedeva un impianto teorico più ampio: una “Teoria Generale” in grado di spiegare anche condizioni di sottoproduzione e disoccupazione persistente.
Contestava l’idea “classica” di un’economia assimilabile a un sistema di baratto, in cui la moneta fungeva solo da velo neutro, influenzando esclusivamente i prezzi e non le variabili reali.
Per Keynes, invece, la moneta è un “fattore operativo”, strettamente legato alle motivazioni e alle decisioni degli individui.
I principi validi in un’economia di baratto non possono essere applicati a un’economia monetaria: la moneta non è soltanto un'unità di conto, ma ciò che collega il presente al futuro.
L’intento di Keynes era quello di completare la teoria economica tradizionale, includendo aspetti fondamentali come i cicli economici, le crisi e la disoccupazione, in cui la moneta e il tasso d’interesse rivestono un ruolo centrale.
2. Domanda effettiva e disoccupazione
Nel modello keynesiano, la domanda aggregata è composta principalmente da consumo e investimento.
Il consumo dipende dal reddito, ma cresce in misura proporzionalmente inferiore rispetto all’aumento del reddito stesso: un comportamento che Keynes definisce “legge psicologica fondamentale”, secondo cui la propensione marginale al consumo è inferiore a uno.
Per esempio, se il reddito di una comunità aumenta di 100 milioni, il consumo potrebbe aumentare soltanto di 80 milioni, mentre i restanti 20 milioni verrebbero risparmiati.
Gli investimenti, al contrario, sono determinati dalle decisioni degli imprenditori e dalle loro aspettative, risultando così esogeni rispetto al flusso circolare del reddito.
Un concetto centrale per comprendere il legame tra investimento e reddito è quello del moltiplicatore: introdotto da Richard Kahn nel 1931 come “moltiplicatore dell’occupazione”, venne successivamente riformulato da Keynes nella Teoria generale come moltiplicatore dell’investimento.
Questo meccanismo, già analizzato nell'articolo precedente, mostra come un determinato livello di investimento possa generare un reddito di equilibrio molto più elevato.
Di conseguenza, si delinea un ruolo "attivo" dell'investimento e uno "passivo" del consumo e del risparmio nel processo di formazione del reddito nazionale.
Tale meccanismo evidenzia il ruolo trainante dell’investimento nella determinazione del reddito nazionale, mentre consumo e risparmio si limitano ad adeguarsi al livello di reddito da esso generato.
In condizioni di elevata disoccupazione, Keynes sosteneva che persino una spesa pubblica apparentemente “inutile” potesse stimolare la crescita economica.
Con un paradosso divenuto celebre per il suo tono provocatorio, Keynes sosteneva che "Se il Tesoro riempisse vecchie bottiglie con banconote, le seppellisse a una profondità adeguata in miniere di carbone dismesse, poi ricoprisse tutto con i rifiuti urbani, e lasciasse che fosse l’iniziativa privata, secondo i collaudati principi del laissez-faire, a scavare per recuperarle… non ci sarebbe più disoccupazione. E, grazie agli effetti indiretti, il reddito reale della collettività, insieme al suo stock di capitale, finirebbe probabilmente per essere molto superiore a quello attuale".
Aggiungeva poi: “Sarebbe, invero, più sensato costruire case e simili; ma se ostacoli politici e pratici si frappongono a ciò, quanto sopra sarebbe meglio di niente”.
L’ironia di Keynes nel proporre scenari paradossali non è mai fine a sé stessa: mira a sottolineare che, in un sistema in cui la spesa – pubblica o privata – rappresenta il motore del reddito e dell’occupazione, il comportamento degli individui non può essere spiegato solo in termini di razionalità.
È proprio in questa direzione che si muove l’analisi keynesiana dell'incertezza, delle aspettative e della fiducia: elementi fondamentali per comprendere le decisioni economiche in un contesto segnato da complessità e imprevedibilità.
3. Incertezza, aspettative e spiriti animali

«Keynes's intellect was the sharpest and clearest that I have ever known. When I argued with him, I felt that I took my life in my hands, and I seldom emerged without feeling something of a fool».
Bertrand Russell
Al centro dell’analisi economica di Keynes si trovano i concetti interconnessi di incertezza, aspettative e fiducia. Secondo Keynes, l’incertezza non è assimilabile a un rischio calcolabile.
Il rischio può essere quantificato statisticamente – come la probabilità di ottenere un sei lanciando un dado – ma l’incertezza, soprattutto quella legata al futuro dell’economia, non può essere ridotta a una misura probabilistica.
Le decisioni di investimento, che spesso si basano su rendimenti attesi nell’arco di dieci o vent’anni, poggiano su “una base di conoscenza molto esigua e spesso trascurabile”.
Il concetto di spiriti animali (animal spirits) è strettamente connesso alle aspettative di lungo periodo, in particolare per quanto riguarda le scelte di investimento.
Secondo Keynes, queste decisioni non derivano solo da un calcolo razionale di rischi e rendimenti, ma anche da un impulso spontaneo all’azione piuttosto che all’inazione. Tale impulso riflette l’inevitabile incertezza soggettiva che accompagna ogni valutazione economica.
Per descrivere la dimensione convenzionale e psicologica dei mercati finanziari, Keynes ricorre alla celebre metafora del concorso di bellezza sui giornali: in questo gioco, non si tratta di scegliere i volti che si ritengono davvero i più belli, né quelli che si pensa la media delle persone giudichi più belli.
Lo scopo è indovinare quali volti l’opinione media si aspetta che gli altri scelgano: un gioco di anticipazione delle aspettative altrui, che ben rappresenta il comportamento degli investitori nei mercati.
L’investitore professionale, quindi, non si concentra tanto sul valore intrinseco di lungo periodo di un titolo, quanto sul cercare di prevedere come si comporterà il mercato nel breve periodo: il suo obiettivo non è determinare quanto dovrebbe valere un’azione, ma indovinare come reagiranno gli altri investitori e, spesso, come questi ultimi si aspettano che reagiscano gli altri ancora.
L’attività finanziaria diventa così un gioco di anticipazione collettiva, più basato sulle aspettative che sui fondamentali economici.
In questo senso, Keynes anticipava di decenni alcune intuizioni che sarebbero poi state formalizzate dagli economisti comportamentali.
L’idea che le decisioni economiche siano influenzate da impulsi, aspettative instabili e percezioni soggettive, più che da calcoli freddamente razionali, è oggi al centro della finanza comportamentale, ma era già presente, con straordinaria lucidità, nella sua analisi.
4. Moneta, interesse e paradossi dell’economia aggregata
Keynes attribuì alla moneta un ruolo centrale nel funzionamento del sistema economico, in netto contrasto con la concezione classica, che la considerava un semplice mezzo di scambio.
La sua celebre affermazione “l’importanza della moneta deriva essenzialmente dal suo essere un legame tra il presente e il futuro” ne riassume efficacemente la funzione essenziale.
La teoria della preferenza per la liquidità è il fulcro dell’interpretazione keynesiana del tasso di interesse. Keynes elenca tre motivi per cui gli individui preferiscono mantenere liquidità anziché investirla:
- Transazionale, legato ai bisogni correnti di spesa.
- Precauzionale, per far fronte a spese impreviste.
- Speculativo, quando si prevede che i tassi di interesse aumenteranno e, di conseguenza, il valore dei titoli scenderà: in questo caso, si preferisce detenere liquidità in attesa di un momento più conveniente per investire.
Il tasso di interesse non remunera il risparmio in sé, ma compensa la rinuncia alla liquidità per un determinato lasso di tempo: chi conserva il denaro inutilizzato, come nel caso di chi lo tiene sotto il materasso, non percepisce alcun interesse.
In altre parole, è la scelta di mantenere liquidità – e non semplicemente l’atto del risparmiare – a determinare il livello del tasso di interesse, soprattutto quello a lungo termine, che a sua volta rappresenta la variabile chiave per l’investimento.
Keynes osservava che questo tasso tende a non scendere al di sotto di una certa soglia, a causa di caratteristiche strutturali: bassa elasticità della sua offerta, costi di mantenimento minimi e limitata sostituibilità.
Questo irrigidimento diventa, a suo avviso, la causa ultima della disoccupazione. In una delle sue formulazioni più incisive, scrisse: “La disoccupazione si manifesta, per così dire, perché la gente desidera l’impossibile: non si possono creare posti di lavoro quando l’oggetto del desiderio, cioè la moneta, è qualcosa che non può essere prodotto e la cui domanda non può essere facilmente repressa”.
A questo quadro si collega anche la critica di Keynes alla Legge di Say e alla cosiddetta “fallacia di composizione”: due temi già trattati nei precedenti articoli dedicati al pensiero di John Maynard Keynes.
Lo stesso ragionamento vale anche a livello internazionale: politiche come la svalutazione competitiva o le restrizioni commerciali possono giovare a un singolo paese nel breve periodo, ma se adottate da tutti finiscono per danneggiare l’intero sistema, generando un impoverimento collettivo.
È il paradosso della razionalità individuale che, elevata a scala sistemica, compromette l’equilibrio generale.
5. Spesa pubblica, investimenti e filosofia sociale
In un’economia afflitta da disoccupazione e domanda effettiva insufficiente, Keynes sosteneva la necessità di un intervento pubblico autonomo per stabilizzare l’occupazione e stimolare la crescita.
Nelle note conclusive della Teoria generale, delinea anche la filosofia sociale implicita nella sua analisi.
Una delle principali giustificazioni per l’elevata concentrazione della ricchezza – l’idea che i risparmi dei ricchi siano essenziali per finanziare l’accumulazione di capitale – perde validità.
In un contesto di sottoccupazione, l’elevato risparmio delle classi più abbienti unito alla loro bassa propensione al consumo, finisce semmai per frenare l’espansione economica, poiché ostacola l’accumulazione di ricchezza.
L’obiettivo di Keynes è più profondo e strutturale: auspica “una socializzazione di una parte considerevole dell’investimento”, non per soppiantare l’iniziativa privata, ma per assicurare che il livello complessivo della produzione si avvicini alla piena occupazione.
Se lo Stato riuscisse a determinare la quantità aggregata degli investimenti e il livello del tasso di interesse di base, avrebbe adempiuto alla sua funzione essenziale: creare le condizioni affinché il capitalismo possa operare in modo efficiente, senza contraddizioni interne.
Da questa visione deriva anche l’idea, provocatoria e simbolica, dell’“eutanasia del rentier”: la graduale scomparsa del capitalista che vive di rendita, resa inevitabile dalla progressiva abbondanza di capitale e dalla conseguente tendenza del tasso di interesse a scendere verso livelli molto bassi.
In definitiva, la Teoria generale sposta il baricentro dell’economia dai problemi microeconomici di allocazione ottimale delle risorse a quelli macroeconomici legati alle fluttuazioni del reddito e dell’occupazione, mettendo in evidenza l’instabilità strutturale del capitalismo, che può trovare equilibrio anche in condizioni di sottoccupazione prolungata.
Pur avendo suscitato critiche e reinterpretazioni nel corso del tempo, l’opera di Keynes resta un riferimento fondamentale per comprendere le dinamiche economiche aggregate e un richiamo permanente alla necessità di misurare la teoria economica con la realtà.
Il libro si chiude con una delle sue riflessioni più celebri, tuttora di grande attualità: “Le idee degli economisti e dei filosofi politici, sia quando sono corrette che quando sono sbagliate, sono molto più potenti di quanto comunemente si ritenga. In realtà, il mondo è governato da ben poco altro. [...] Prima o poi, sono proprio le idee, e non gli interessi consolidati, a rivelarsi determinanti, nel bene e nel male”.
La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:
1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone
2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone
3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica
4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno
5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti
6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica
7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo
8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito
9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say
10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi
11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero
12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico
13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier
14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero
15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale
16. Karl Marx: La teoria del valore
17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico
18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto
19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista
20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista
21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità
22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher
23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità
24. La Scuola Storica Tedesca di economia
25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale
26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano
27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico
28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta
29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises
32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione
33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità
34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia
35. Piero Sraffa
...