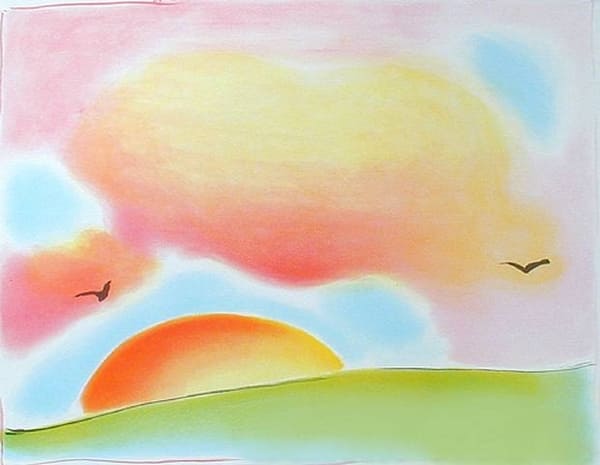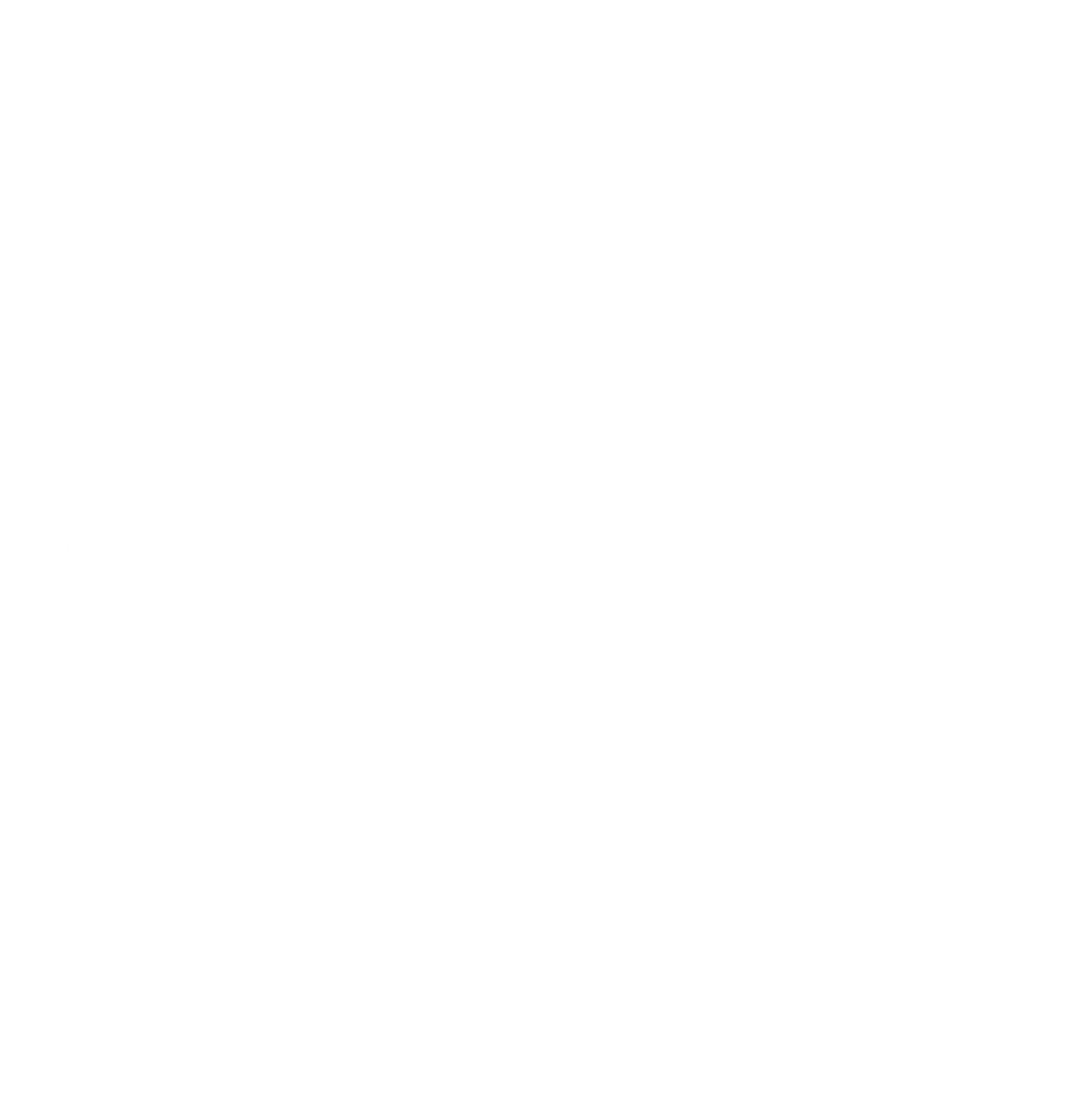Ludwig von Mises e la scienza dell’azione umana: libertà, mercato e conoscenza
- Information
- Storia del pensiero economico
- Prima pubblicazione: 22 Novembre 2025
«Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono».
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Le premesse metodologiche e filosofiche elaborate da Mises trovano piena espressione nella sua opera matura, Human Action, in cui la teoria diventa una riflessione sistematica sull’intero ordine economico e sociale.
In quest’opera, la prasseologia — la scienza dell’azione umana — si traduce in un’analisi dei grandi problemi del suo tempo: dal funzionamento dei mercati alla natura del denaro, dai cicli economici alla pianificazione centralizzata.
Mises mostra come ogni fenomeno economico abbia origine nelle scelte individuali e come la cooperazione sociale emerga spontaneamente dal libero scambio tra persone che agiscono perseguendo i propri fini.
Indice
- Le principali teorie misesiane: il calcolo economico e il ciclo del credito
- Critiche, eredità e attualità del pensiero austriaco
1. Le principali teorie misesiane: il calcolo economico e il ciclo del credito
L’architettura teorica della prasseologia misesiana trova la sua piena applicazione in due ambiti fondamentali: la critica al socialismo e la spiegazione dei cicli economici.
Entrambe le elaborazioni muovono dalla stessa radice logica, l’azione umana come processo di scelta razionale in condizioni di scarsità, e conducono Mises a risultati profondamente innovativi, spesso in contrasto con le correnti economiche dominanti del suo tempo.
La critica al calcolo economico nel socialismo
Nel 1920, Mises pubblicò un breve saggio dal titolo Economic Calculation in the Socialist Commonwealth.
In poche pagine smontò la convinzione, allora largamente condivisa, che un’economia pianificata potesse eguagliare o addirittura superare in efficienza il sistema di mercato.
L’argomentazione di Mises era fondata su basi puramente logiche ed economiche e non conteneva giudizi di ordine morale o politico.
Mises parte da una domanda solo in apparenza semplice: come può un'autorità di pianificazione decidere come allocare risorse scarse tra usi alternativi senza un sistema di prezzi di mercato?
In un’economia di mercato, i prezzi dei beni di consumo e dei fattori produttivi riflettono le valutazioni soggettive di milioni di individui: il prezzo è un vero e proprio mezzo di comunicazione che racchiude informazioni diffuse sul valore e sulla scarsità dei beni.
Quando, invece, i mezzi di produzione sono di proprietà collettiva, come in un sistema socialista, vengono meno gli scambi di mercato per tali beni e, di conseguenza, non esistono prezzi di mercato effettivi, ovvero formati dal libero incontro tra domanda e offerta.
Senza prezzi, l'autorità di pianificazione centrale non può confrontare i costi di un progetto con i benefici che produce, né stabilire se una certa quantità di acciaio o di lavoro debba essere destinata a un ponte, a una fabbrica o a un ospedale.
La pianificazione, in assenza del sistema dei prezzi, diventa così una navigazione nel buio: si possono fissare obiettivi generici, come “il benessere del popolo”, ma mancano i criteri per valutare la razionalità economica dei mezzi scelti per raggiungerli.
In questo senso, Mises distingue in modo netto la conoscenza tecnica dalla conoscenza economica.
Un ingegnere può sapere come costruire dieci tipi diversi di ponti, ma solo i prezzi di mercato possono indicargli quale di questi progetti sia economicamente sostenibile.
Il socialismo, osserva Mises, può produrre ma non può calcolare: può formulare piani, ma non è in grado di stabilire se essi migliorino o peggiorino il benessere della società.
In altre parole, il fallimento del socialismo è causato dall’assenza del meccanismo di coordinamento che, nel mercato, permette alle azioni individuali di convergere verso un ordine coerente. Senza mercato, manca lo strumento conoscitivo attraverso il quale la società scopre le soluzioni efficienti ai propri problemi di scarsità.
Negli anni Trenta, questa tesi diede origine a uno dei dibattiti più celebri nella storia del pensiero economico: il "Dibattito sul calcolo socialista", che coinvolse economisti come Oskar Lange, Enrico Barone e Friedrich von Hayek.
Lange tentò di replicare a Mises sostenendo che un’autorità centrale avrebbe potuto simulare il mercato, fissando i prezzi e correggendoli progressivamente fino a raggiungere un equilibrio.
Ma, per Mises, questa era un’illusione: il problema era di conoscenza e non tanto di natura matematica. Solo la concorrenza effettiva e la responsabilità personale degli imprenditori generano informazioni genuine sui valori economici.
Il socialismo, privando il sistema dei segnali di prezzo, finisce per distruggere il tessuto informativo stesso dell’economia: si tratta di un’intuizione che il corso degli eventi avrebbe confermato.
La forza della critica misesiana risiede quindi anche nella sua capacità di anticipare la storia. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, molti studiosi hanno riconosciuto nella diagnosi di Mises una previsione sorprendentemente lucida dell’inefficienza e della stagnazione proprie dei sistemi pianificati.
Le economie socialiste, prive di segnali di prezzo e di incentivi imprenditoriali, accumularono errori sistematici di allocazione e sprechi ingenti di risorse.
Il “caos pianificato” prefigurato da Mises trovò conferma nella realtà.
La teoria austriaca del ciclo economico
Il secondo grande contributo di Mises riguarda la spiegazione delle fluttuazioni economiche: le fasi di espansione e contrazione che caratterizzano le economie di mercato.
In collaborazione con il suo allievo Friedrich von Hayek, egli sviluppò una teoria coerente con i principi della prasseologia e fondata sull’analisi del credito e del tasso d’interesse.
Nel pensiero austriaco, il tasso d’interesse svolge una funzione essenziale: riflette la preferenza temporale degli individui, ossia il rapporto tra il valore attribuito ai beni presenti e quello assegnato ai beni futuri.
Quando la società risparmia molto, il tasso d’interesse tende a diminuire, segnalando la presenza di risorse reali disponibili per finanziare investimenti di lungo periodo.
Al contrario, se la propensione al risparmio è bassa, il tasso sale, scoraggiando progetti troppo ambiziosi o costosi.
Il problema sorge quando le autorità monetarie – in particolare le banche centrali – intervengono artificialmente sul mercato del credito, espandendo la massa monetaria e riducendo i tassi al di sotto del loro livello “naturale”.
Questo falso segnale induce gli imprenditori a credere che vi siano più risparmi reali di quelli effettivamente disponibili.
Ne consegue un’ondata di nuovi investimenti, soprattutto nei settori a lungo ciclo produttivo come l’edilizia, le grandi opere o l’industria pesante, dando origine a una fase di boom.
Tali progetti, tuttavia, non poggiano su risorse reali: si tratta di malinvestments, ossia investimenti errati o prematuri, destinati prima o poi a rivelarsi insostenibili.
Quando l’espansione del credito si arresta o l’inflazione mina la fiducia nella moneta, i tassi tornano a salire e il sistema è costretto a liquidare gli investimenti improduttivi. Ha così inizio la fase di crisi o bust, in cui il capitale mal allocato deve essere riconvertito o distrutto.
Per Mises, la crisi è un necessario processo di correzione degli errori accumulati durante il boom.
Il ciclo economico è quindi la conseguenza diretta dell’interferenza delle autorità monetarie, che alterano i segnali del mercato del credito.
Il rimedio non risiede in ulteriori interventi, ma nel ritorno a una moneta solida e a tassi d’interesse liberi, capaci di riflettere le reali preferenze temporali degli individui.
La teoria misesiana del ciclo anticipa molte delle preoccupazioni contemporanee legate alla finanziarizzazione e all’espansione creditizia incontrollata.
Anche in questo caso, dopo la crisi del 2008 diversi economisti hanno riscoperto in Mises e Hayek una chiave interpretativa di grande attualità: la sovrabbondanza di credito e la manipolazione dei tassi da parte delle banche centrali generano squilibri strutturali che inevitabilmente conducono a recessioni.
A dire il vero, fino ad oggi – novembre 2025 – la tanto annunciata recessione non si è ancora manifestata. Arriverà? Se sì, quando? Sono domande a cui solo il tempo potrà dare una risposta.
Rimane comunque il fatto che la teoria austriaca continua a rappresentare un monito contro le illusioni del denaro facile e dell’espansione monetaria.
L’imprenditore come protagonista del processo economico
Un elemento centrale che collega le due principali teorie misesiane, quella del calcolo economico nel socialismo e quella del ciclo economico, è la figura dell’imprenditore.
In entrambe, Mises riconosce il suo ruolo insostituibile come agente di coordinamento in un contesto dominato dall’incertezza.
L’imprenditore è colui che scopre informazioni, collega bisogni e risorse, si assume dei rischi e, nel farlo, contribuisce a trasformare il caos in ordine.
Senza la libertà imprenditoriale e senza la disciplina del profitto e della perdita, non può emergere l’informazione economica che guida le scelte di mercato.
Per Mises, il mercato è quindi un processo imprenditoriale ininterrotto, in cui l’errore è necessario affinché la società possa progredire.
In sintesi, le due grandi teorie misesiane delineano una visione unitaria dell’economia come ordine spontaneo:
- Il mercato dei beni e del credito è un processo di scoperta e non un meccanismo di comando.
- La moneta e i prezzi sono i codici attraverso cui la società comunica e coordina le proprie azioni.
- L’imprenditore trasforma le informazioni diffuse nel mercato in decisioni economiche concrete.
2. Critiche, eredità e attualità del pensiero austriaco

«The Austrian a priori dogmatism».
Kenneth Arrow, on question "In your mind, what has been the most misleading theoretical approach in economics?"
L’influenza esercitata da Ludwig von Mises e della Scuola Austriaca sul pensiero economico del Novecento è stata profonda e duratura, pur suscitando forti controversie.
Per gran parte del secolo, gli economisti austriaci sono stati considerati eretici rispetto al mainstream accademico, orientato verso l’approccio matematico, l’analisi statistica e le politiche macroeconomiche di ispirazione keynesiana.
Eppure, molte delle loro intuizioni – dal ruolo della conoscenza diffusa ai limiti della pianificazione centrale – si sono rivelate di sorprendente attualità, soprattutto alla luce delle crisi economiche e finanziarie degli ultimi decenni.
Per cogliere la portata del pensiero austriaco è utile metterne in luce sia i punti di forza – coerenza, realismo e umanesimo – sia le critiche che ne hanno accompagnato la ricezione nel dibattito economico contemporaneo.
Punti di forza: coerenza, realismo e umanesimo
Il primo punto di forza della Scuola Austriaca risiede nella coerenza logica del suo impianto teorico.
A differenza di molte dottrine che cercano di conciliare modelli eterogenei, il pensiero austriaco si fonda su pochi principi chiari e strettamente connessi: l’individualismo metodologico, il soggettivismo, l’incertezza, la conoscenza diffusa e la centralità del processo imprenditoriale.
A partire da questi assiomi, Mises e in seguito Hayek hanno costruito un sistema capace di spiegare sia il funzionamento del mercato che le cause dei suoi squilibri.
Ma il merito della Scuola Austriaca è anche epistemologico e, in un certo senso, morale: in un’epoca in cui l’economia tende a ridurre l’essere umano a una variabile di calcolo, Mises ricorda che essa è innanzitutto una scienza dell’azione, e dunque una scienza dell’uomo.
Ogni scelta economica rappresenta un atto di libertà, ma anche di responsabilità: l’individuo agisce sempre all’interno di una rete di relazioni, aspettative e cooperazione.
Questa prospettiva restituisce alla teoria economica un fondamento umanistico che molte altre scuole hanno progressivamente smarrito.
La visione austriaca è inoltre profondamente realista: riconosce i limiti della conoscenza, l’incertezza del futuro e la fallibilità delle istituzioni.
Per gli economisti austriaci, la razionalità consiste nella capacità di apprendere dagli sbagli: in questo senso, la concorrenza è un processo educativo oltre che economico.
Le principali critiche
Il pensiero austriaco ha naturalmente suscitato numerose obiezioni, provenienti sia dal mondo accademico sia da economisti più orientati verso un approccio pratico.
La prima, e forse la più frequente, riguarda il cosiddetto metodo aprioristico di Mises: molti economisti, da Paul Samuelson a Milton Friedman, gli rimproverarono di aver costruito una teoria difficilmente verificabile sul piano empirico, fondata su deduzioni logiche più che su osservazioni e dati.
Secondo tali critici, in assenza di possibilità di falsificazione, l’economia rischierebbe di trasformarsi in filosofia o in ideologia.
Mises replicò che questa obiezione nasce da un fraintendimento: confonde il piano delle scienze naturali con quello delle scienze dell’azione. Nel campo dell’agire umano non esistono esperimenti ripetibili, poiché ogni fenomeno economico è unico e irripetibile, frutto di decisioni individuali in contesti specifici.
L’economia, di conseguenza, non può essere falsificata come la fisica, ma può essere compresa attraverso la logica dell’azione e l’analisi storica dei risultati.
La sua ambizione, sosteneva Mises, è interpretare le regolarità del comportamento umano, più che prevedere il verificarsi dei singoli eventi.
Un’altra critica, di natura più pratica e politica, riguarda il laissez-faire sostenuto dalla tradizione austriaca.
I detrattori osservano che la fiducia nel mercato tenderebbe a ignorare problemi reali delle economie moderne, come le esternalità, i beni pubblici, le disuguaglianze e l’instabilità finanziaria.
Gli economisti austriaci non negano l’esistenza di questi fenomeni, ma li interpretano come conseguenze di distorsioni istituzionali o monetarie introdotte dallo Stato.
Per Mises, le crisi economiche sono il risultato di distorsioni monetarie generate da espansioni creditizie e manipolazioni dei tassi d’interesse: non fallisce il mercato, ma la moneta.
Quanto alle disuguaglianze, sostiene che siano causate dagli interventi che creano e mantengono privilegi e monopoli.
Per finire, alcuni critici – in particolare sul piano etico e politico – hanno accusato Mises di ridurre la vita sociale a un mero scambio, trascurando valori come la solidarietà o la giustizia sociale.
Anche in questo caso, tuttavia, il fraintendimento sembra essere più apparente che reale: Mises non respinge la solidarietà, ma la coercizione.
Egli distingue chiaramente tra cooperazione volontaria e redistribuzione imposta: in una società di mercato, le persone possono aiutarsi reciprocamente proprio perché dispongono dei propri mezzi e della libertà di scegliere come usarli.
In questa prospettiva, la libertà economica costituisce la condizione stessa della solidarietà.
L’eredità intellettuale
Dopo la Seconda guerra mondiale, il pensiero misesiano trovò nuova vitalità grazie a Friedrich von Hayek, suo allievo e interlocutore, che nel 1974 vinse il Premio Nobel per l’economia.
Hayek sviluppò l’intuizione di Mises sul ruolo della conoscenza, elaborando la teoria dell’ordine spontaneo e una critica al razionalismo costruttivista.
Negli anni successivi, altri economisti come Israel Kirzner, Murray Rothbard e Ludwig Lachmann hanno ampliato la tradizione austriaca in direzioni differenti.
Kirzner ha posto l’accento sul ruolo dell’imprenditore come scopritore di opportunità; Rothbard ha sistematizzato la filosofia libertaria in chiave etico-politica; Lachmann ha approfondito il tema dell’incertezza radicale, avvicinandosi a un approccio di tipo interpretativo.
Tutti, però, condividono la stessa convinzione di fondo: la conoscenza economica è diffusa, dinamica e inaccessibile a qualsiasi centro di controllo.
Nel mondo contemporaneo, le idee di Mises e della Scuola Austriaca hanno conosciuto una rinnovata attenzione: la crisi del 2008, l’espansione monetaria senza precedenti e la crescita dei debiti pubblici hanno riaperto il dibattito sui limiti dell’interventismo e sulla sostenibilità del denaro fiat.
Economisti, imprenditori e studiosi del movimento sound money – favorevole a una moneta solida e indipendente dal potere politico – e del mondo delle criptovalute, in particolare di Bitcoin, trovano nella teoria austriaca una chiave interpretativa per comprendere i rischi di inflazione, le distorsioni creditizie e la perdita di fiducia nelle istituzioni monetarie.
Attualità del pensiero austriaco
In un’economia globale e interconnessa, dove decisioni e informazioni superano ogni possibilità di coordinamento centrale, la riflessione di Ludwig von Mises sui limiti della conoscenza e della pianificazione rimane di grande rilevanza.
Molte delle tensioni economiche e sociali del nostro tempo derivano, forse, dalla pretesa di governare dall’alto processi che nascono spontaneamente dalla cooperazione tra individui.
La Scuola Austriaca ricorda che il mercato è un ordine vivente di cooperazione, che l’economia è un processo di creazione continua di valore e che la libertà economica è la condizione essenziale della dignità individuale.
Questa idea trova la sua espressione più forte nella condanna che Mises formula, in Human Action, contro l’interventismo statale: “Every step a government takes beyond the fulfillment of its essential functions of protecting the smooth operation of the market economy against aggression, whether on the part of domestic or foreign disturbers, is a step forward on a road that directly leads into the totalitarian system where there is no freedom at all”.
Conclusioni
L’eredità di Ludwig von Mises e della Scuola Austriaca consiste in un modo di guardare l’economia attraverso l’azione umana, intesa come espressione della libertà e della razionalità individuale.
Si tratta di un invito alla responsabilità personale, alla misura e alla consapevolezza dei limiti della conoscenza umana.
Nel mostrare che la società nasce dalla cooperazione spontanea e non dal disegno di un’autorità centrale, Mises offre una lezione di umiltà intellettuale e una difesa della libertà come principio della civiltà.
Questo percorso trova la sua continuazione naturale nel pensiero di Friedrich von Hayek, che amplia l’orizzonte misesiano.
Mises chiarisce la logica dell’azione individuale; Hayek ne evidenzia la dimensione evolutiva, mostrando come dall’interazione tra individui emerga un ordine capace di adattarsi e progredire.
Il prossimo approfondimento sarà dedicato a questo passaggio: comprendere come Hayek abbia esteso l’intuizione misesiana, trasformandola in una filosofia della libertà applicata all’economia, alla società e alle istituzioni politiche.
La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:
1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone
2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone
3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica
4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno
5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti
6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica
7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo
8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito
9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say
10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi
11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero
12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico
13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier
14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero
15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale
16. Karl Marx: La teoria del valore
17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico
18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto
19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista
20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista
21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità
22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher
23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità
24. La Scuola Storica Tedesca di economia
25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale
26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano
27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico
28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta
29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises
32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione
33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità
34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia
35. Piero Sraffa
...