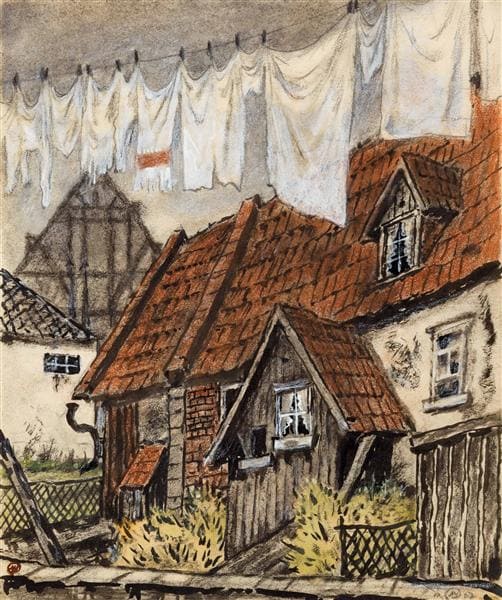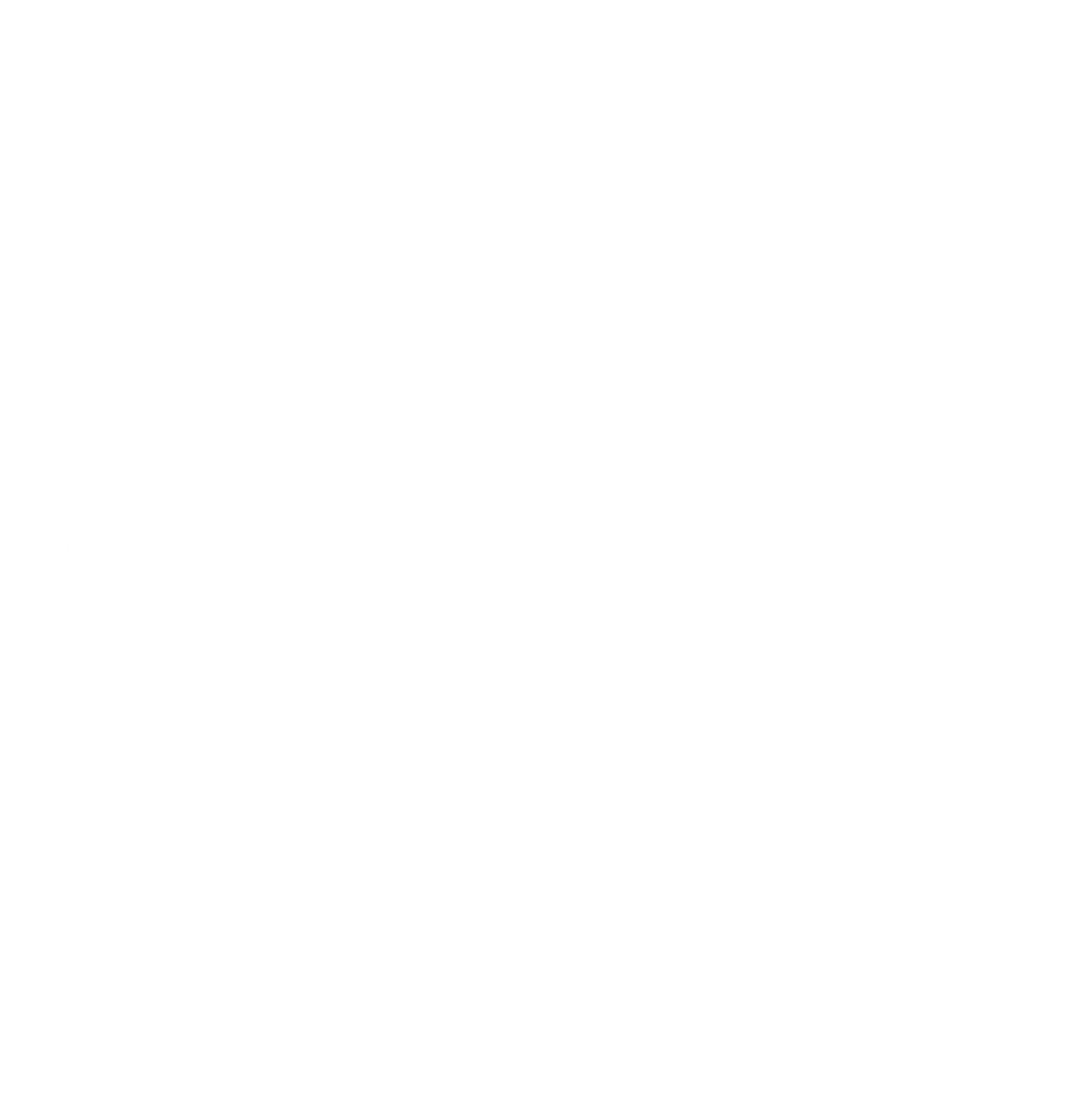La Scuola Storica Tedesca: un’economia plasmata dalla storia e dalle istituzioni
- Information
- Storia del pensiero economico
- Prima pubblicazione: 29 Giugno 2025
«An individual, in promoting his own interest, may injure the public interest; a nation, in promoting the general welfare, may check the interest of a part of its members».
Friedrich List
Sviluppatasi in Germania intorno alla metà del XIX secolo e dominante nel panorama accademico tedesco fino ai primi decenni del XX, la Scuola Storica Tedesca rappresenta una delle correnti più distintive e influenti nella storia del pensiero economico.
La Scuola Storica si distinse nettamente da tutte le altre correnti del pensiero economico, in quanto propose una revisione radicale dei fondamenti metodologici e degli stessi obiettivi della disciplina economica.
La Scuola si pose in aperta contrapposizione all’approccio astratto e universalistico dell’economia classica e, in seguito, di quella neoclassica.
Indice
- Il contesto storico-culturale e le radici della Scuola Storica nel pensiero tedesco
- I fondamenti metodologici: induttivismo e rifiuto delle astrazioni universali
- I principali esponenti della Scuola Storica Tedesca
- Punti di forza e critiche alla Scuola Storica
- Eredità e rilevanza contemporanea
1. Il contesto storico-culturale e le radici della Scuola Storica nel pensiero tedesco
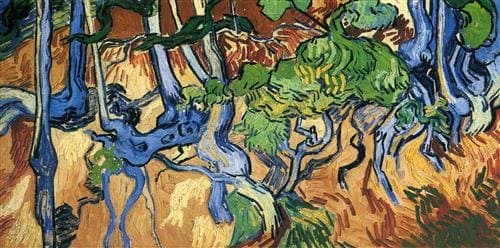
La nascita della Scuola Storica si inquadra nel clima intellettuale del romanticismo e dello storicismo tedesco.
Questi movimenti filosofici rifiutavano l’idea illuminista di principi universali e immutabili che regolassero la società come leggi fisiche, preferendo invece mettere in luce l’unicità storica e culturale di ogni epoca, cultura e nazione.
In questa prospettiva, l’economia non poteva essere separata dalla sua dimensione storica e geografica.
A differenza di altre tradizioni accademiche, come quella nordamericana, dove la pubblicazione di articoli era (e resta) parte integrante della carriera accademica, nelle università europee l’attenzione alla pubblicazione scientifica era marginale.
Al contrario, la tradizione orale godeva spesso di maggiore prestigio.
È probabile che proprio un ambiente accademico meno formalizzato e più aperto al confronto abbia favorito lo sviluppo di un pensiero economico meno incline all’astrazione e più attento all’osservazione di situazioni concrete, storicamente e geograficamente determinate.
Un’importante radice intellettuale della Scuola Storica fu il cameralismo, sviluppatosi nei territori di lingua tedesca fra il XVII e il XVIII secolo.
I cameralisti, una sorta di proto-economisti o più semplicemente degli amministratori pubblici, si concentravano sulla gestione concreta delle finanze e dell’amministrazione statale.
Il loro approccio era basato più sull’elaborazione di regole pratiche tratte dall’esperienza che sulla costruzione di modelli teorici.
Le conoscenze che ne scaturivano erano frutto dell’attenta registrazione e analisi sistematica di dati statistici, anticipando così l’approccio empirico che sarebbe diventato centrale per la Scuola Storica Tedesca.
Ad esempio, i cameralisti promuovevano l’incremento demografico per ragioni pratiche: l’esperienza delle devastazioni provocate da guerre e pestilenze, come la Guerra dei Trent’anni, aveva insegnato loro che una popolazione numerosa rappresentava una risorsa essenziale per lo Stato.
Figure come Georg H. Zincke (considerato un pioniere della gestione aziendale) e Johann H. G. von Justi rappresentano esempi emblematici di questa tradizione cameralistica.
Entrambi mostrarono un forte interesse per la redditività e l’organizzazione della produzione agricola, prestando particolare attenzione a variabili concrete come i costi di trasporto.
La loro opera anticipava perciò l’approccio metodologico della futura Scuola Storica Tedesca, basato su un sapere concreto, misurabile e storicamente fondato.
In questo filone di pensiero si possono riconoscere affinità anche con autori precedenti, come James Steuart, economista mercantilista del XVIII secolo che adottò un approccio induttivo e comparativo, criticando duramente la cosiddetta "teoria da poltrona" (armchair theorizing).
Pur appartenendo a una tradizione diversa, Steuart condivideva il rifiuto delle generalizzazioni astratte e l’enfasi sull’analisi empirica e storica, anticipando alcune delle critiche metodologiche che sarebbero poi divenute centrali nella Scuola Storica Tedesca.
2. I fondamenti metodologici: induttivismo e rifiuto delle astrazioni universali
Alla base del metodo della Scuola Storica Tedesca vi era un induttivismo fondato sull’analisi empirica dei dati storici.
Secondo questa impostazione, le leggi economiche – ammesso che esistano – non sono né universali né atemporali, ma valide solo all’interno di specifici contesti storici e culturali.
La conoscenza economica doveva quindi essere costruita dal basso, attraverso l’osservazione sistematica e l’analisi dei dati storici e statistici.
Invece di partire da assunti astratti, come l’idea che gli esseri umani massimizzano sempre la propria utilità (tipica dell’approccio deduttivo), per ricavarne il funzionamento ideale del mercato, la Scuola Storica Tedesca seguiva il percorso inverso: analizzava centinaia di mercati reali, dalla Firenze rinascimentale alla Londra vittoriana, per osservare se da questi casi emergessero regolarità nei comportamenti.
Gustav Schmoller definiva l’approccio induttivo una “procedura tecnologica” e mirava ad applicare il metodo sperimentale anche alle scienze sociali, servendosi dell’indagine storica.
Le generalizzazioni prodotte erano valide solo all’interno di periodi definiti di circostanze culturali simili (bestimmter wirtschaftlicher Kulturzustand).
La Scuola Storica rifiutava anche l’impiego di assunzioni come il ceteris paribus (a parità di condizioni), considerandolo al più una scorciatoia intellettuale utile a semplificare problemi complessi, ma a discapito del realismo.
Nella loro visione, infatti, il ceteris paribus era “praticamente impossibile” nelle scienze sociali, dove tutti i fattori sono interconnessi e non isolabili.
Un’altra importante critica riguardava la consapevolezza che ogni osservazione è “carica di teoria”, ovvero inevitabilmente influenzata da idee e ipotesi preesistenti.
Ciò rendeva artificiosa, agli occhi della Scuola Storica, la separazione tra giudizi analitici e sintetici, o tra fatti e teorie: una distinzione centrale nel pensiero positivista che essi cercavano di superare.
Da questa impostazione derivava anche un profondo scetticismo verso ogni pretesa di universalità: Schmoller, ad esempio, criticava Adam Smith per non aver colto appieno le implicazioni della rivoluzione tecnica.
Secondo lui, Smith non aveva riconosciuto la necessità di riformare le istituzioni economiche tradizionali, come il libero mercato deregolamentato o il sistema corporativo, e di introdurne di nuove, più adatte alla società industriale emergente, come forme di protezione sociale, intervento pubblico e legislazione del lavoro.
Per la Scuola Storica, infatti, le “leggi” economiche non erano né eterne né immutabili, ma dovevano adattarsi all’evoluzione storica e sociale.
3. I principali esponenti della Scuola Storica Tedesca

«Fashion is capitalism’s favourite child».
Werner Sombart
La Scuola Storica Tedesca annovera tra le sue fila alcune delle figure più influenti del pensiero economico dell’epoca, ciascuna delle quali contribuì in modo specifico alla definizione dell’approccio storico-istituzionale.
Friedrich List (1789-1846)
Vissuto prima della piena affermazione della Scuola Storica, List ne rappresenta comunque un importante precursore per l’enfasi posta sul contesto nazionale dell’economia.
List sosteneva che la prosperità e la sicurezza di uno Stato dipendessero dalla sua indipendenza economica e politica.
Nella sua opera principale, Das nationale System der politischen Oekonomie (1841), sviluppò la "Teoria delle potenze produttive", che superava la semplice misurazione della ricchezza in termini di beni prodotti, includendo invece fattori come l’istruzione, le infrastrutture e l’organizzazione sociale.
List concepiva lo sviluppo economico come un processo in più fasi (pastorizia, agricoltura, agricoltura e manifattura, ecc.), per cui la politica economica doveva adattarsi allo stadio evolutivo della nazione.
Tra le misure proposte vi erano anche i dazi temporanei, pensati per proteggere le industrie nazionali emergenti fino a quando non fossero diventate abbastanza forti da competere con quelle straniere.
Promuoveva inoltre la rappresentanza popolare e la trasparenza nei processi decisionali, auspicando l’introduzione di un’analisi scientifica dell’amministrazione pubblica anche in ambito universitario.
Gustav Schmoller (1838–1917)
Figura centrale della cosiddetta “giovane” Scuola Storica, Schmoller fu influenzato da una formazione familiare improntata al metodo scientifico: il nonno era un biologo e chimico impegnato nella ricerca sperimentale.
Promosse le Detailuntersuchungen (indagini di dettaglio) come metodo per analizzare le connessioni causali all’interno di contesti storici e geografici specifici, mirando a un’applicazione del metodo sperimentale alle scienze sociali.
Schmoller riteneva che l’umanità dovesse intervenire consapevolmente nell’ordine naturale, e considerava ogni progresso ottenuto contro l’imprevedibilità del caso come un avanzamento della civiltà.
Questa visione ispirava il suo “socialismo della cattedra”, secondo cui lo Stato e il mondo accademico dovevano promuovere le riforme necessarie per armonizzare gli interessi sociali e affrontare la “questione sociale” posta dall’industrializzazione.
Il suo obiettivo era trasformare l'ordine naturale del laissez-faire in un “ordine culturale” in cui le istituzioni garantissero condizioni di vita dignitose per tutti.
È probabilmente per questo motivo che Schmoller ammirava il “secondo” John Stuart Mill, quello attento alle questioni sociali e politiche, tanto da volergli conferire una laurea honoris causa.
Werner Sombart (1863–1941)
Sombart è noto per i suoi studi sul capitalismo moderno e per l’adozione della metodologia del Verstehen (comprendere), derivata dalla tradizione sociologica tedesca.
Il suo obiettivo era analizzare come, da contesti storici e culturali specifici, emergessero sistemi economici con caratteristiche proprie, così da comprenderne le logiche interne e orientare su questa base le scelte di politica sociale.
Secondo Sombart, ogni sistema economico è definito da tre elementi: spirito, organizzazione e tecnica.
Lo spirito includeva i valori e le motivazioni che guidano le azioni individuali; l’organizzazione riguardava le strutture sociali e istituzionali; la tecnica si riferiva ai metodi e ai mezzi materiali di produzione (macchinari, infrastrutture e così via).
Pur considerando la famiglia contadina il modello economico più autentico, Sombart non ignorava la realtà industriale: criticava il lavoro salariato per la sua natura spersonalizzante, ma immaginava per i lavoratori un modello di “vita dignitosa”, basato su salari adeguati, igiene, orari sostenibili, partecipazione comunitaria e accesso alla vita culturale.
In questo senso, Sombart può essere considerato un precursore del moderno Stato sociale: auspicava infatti un intervento pubblico capace di garantire condizioni minime di dignità, salute e partecipazione per tutti i lavoratori.
Questa sua apertura intellettuale si manifestava anche nel metodo: Sombart accettava che approcci teorici diversi potessero offrire strumenti utili a seconda del contesto analizzato, rifiutando visioni dogmatiche in favore di una maggiore flessibilità interpretativa.
4. Punti di forza e critiche alla Scuola Storica
La Scuola Storica Tedesca, con il suo originale approccio, ha lasciato un'impronta profonda nel pensiero economico, pur attirando numerose critiche, sia sul piano teorico che metodologico.
Punti di Forza
1. Approccio olistico e interdisciplinare. La Scuola riconobbe che l’economia non agisce in isolamento e, seguendo l'esempio di pensatori come John Locke e Adam Smith, mantenne una visione integrata e multidisciplinare del sapere.
Valorizzò in particolare l’interconnessione tra fenomeni economici, politici, sociali e culturali, sottolineando il ruolo delle istituzioni come espressione dei costumi e della cultura di un popolo.
2. Enfasi sull'empirismo e sulla storia. Attraverso una vasta e rigorosa raccolta di dati e un’attenta indagine storica, la Scuola pose le basi per futuri approcci empirici dell’economia.
Un esempio emblematico è quello di Johann Heinrich von Thünen che, nella sua tenuta di Tellow, sviluppò un sistema contabile meticoloso per stimare rese e costi in modo scientifico.
Il suo lavoro anticipò strumenti oggi fondamentali nell’economia applicata, come ad esempio l’analisi costi-benefici.
3. Preoccupazione per la "questione sociale". Molti esponenti della Scuola affrontarono i problemi causati dall’industrializzazione. Von Thünen, ad esempio, concepiva il “salario naturale” come una richiesta etica e auspicava il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori attraverso un’adeguata istruzione.
Questa sensibilità etica si tradusse anche in critiche alla proprietà privata, talvolta ritenuta promotrice di atteggiamenti antisociali come l’egoismo o l’arroganza.
4. Sviluppo metodologico critico. La Scuola contribuì in modo significativo al dibattito metodologico, sostenendo come le leggi economiche non possano essere universali e che ogni osservazione sia inevitabilmente “carica di teoria”, cioè influenzata da premesse concettuali.
Lo scetticismo verso strumenti come il ceteris paribus alimentò una riflessione ancora attuale sulla validità delle astrazioni teoriche e sull’importanza del contesto storico nei modelli economici.
Critiche
1. Methodenstreit: la disputa metodologica. La controversia più nota fu quella con Carl Menger, fondatore della Scuola Austriaca, che criticava il rifiuto dell’astrazione da parte della Scuola Storica.
A suo avviso, ogni osservazione richiede concetti generali e astrazioni, e grazie al principio di causalità è possibile trarre inferenze empiricamente valide senza rinunciare al rigore logico.
Abbiamo approfondito il Methodenstreit anche nell’articolo dedicato alla Scuola Austriaca.
2. Carenza di teorie generali e di rigore analitico. Una delle critiche principali riguarda la difficoltà della Scuola nel formulare teorie sistematiche e generalizzabili.
Il suo approccio venne spesso considerato troppo descrittivo e poco teorico. Anche al suo interno emersero divergenze: Schmoller, ad esempio, rimproverava a Sombart un’eccessiva soggettività nei suoi giudizi.
Inoltre, alcune previsioni formulate da Sombart come il declino del commercio estero o della produttività si rivelarono errate nel lungo periodo, alimentando dubbi sulla solidità empirica delle conclusioni della Scuola.
3. Contrasto con approcci contrari all’intervento pubblico. Pensatori come Vilfredo Pareto si opposero radicalmente alla visione riformista della Scuola Storica.
Con la sua celebre “legge 80/20”, definita anche Principio di Pareto, sosteneva che la distribuzione della ricchezza fosse il risultato di differenze innate tra individui, rendendo inefficaci le politiche redistributive.
Secondo questa prospettiva, ogni tentativo di ridurre le disuguaglianze era destinato a fallire, poiché la ricchezza tenderebbe comunque a riconcentrarsi nelle mani di pochi: una visione in netto contrasto con l’umanesimo sociale promosso da molti esponenti della Scuola Storica.
5. Eredità e rilevanza contemporanea
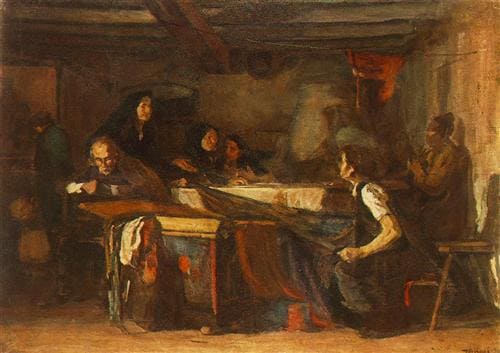
Sebbene la Scuola Storica Tedesca abbia progressivamente perso centralità nel dibattito economico, la sua eredità rimane profonda e continua a influenzare molte correnti teoriche e riflessioni metodologiche contemporanee.
Influenza diretta: l'istituzionalismo americano
Una delle eredità più evidenti si ritrova nell’istituzionalismo americano.
Autori come Thorstein Veblen ripresero la critica all’astrazione della teoria neoclassica e riaffermarono il ruolo delle istituzioni come motori dello sviluppo economico.
Questo approccio è stato ripreso e rinnovato nel neo-istituzionalismo contemporaneo, un insieme di teorie che, pur con metodi differenti, attribuiscono un ruolo centrale alle istituzioni nella spiegazione dei comportamenti economici.
Influenze metodologiche trasversali
- Alfred Marshall. Fondatore della scuola neoclassica, Marshall mostrò tuttavia una certa diffidenza verso il metodo assiomatico-deduttivo. La sua attenzione alla pluralità dei comportamenti umani, all’evoluzione storica dei concetti e alla complessità dei meccanismi di equilibrio lo rende un punto di contatto tra la tradizione marginalista e la sensibilità storica della Scuola Storica.
- Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter auspicava una scienza economica capace di integrarsi con la sociologia, riconoscendo che i fenomeni economici sono profondamente radicati nelle strutture sociali e nei processi storici.
- John Maynard Keynes. Keynes condivideva diverse istanze metodologiche della Scuola Storica: rifiutava i modelli rigidi, privilegiava il ragionamento induttivo e considerava l’economia come uno strumento per interpretare il mondo reale.
- Friedrich August Hayek. Nonostante fosse un convinto sostenitore del libero mercato, Hayek sosteneva l’importanza della “conoscenza dispersa”, cioè la diffusione delle informazioni tra molte persone, ognuna con la propria esperienza. Questa idea, anche se con fini diversi, ricorda la visione della Scuola Storica Tedesca, che sottolineava l’importanza del contesto e dei limiti della conoscenza nei fenomeni economici.
Conclusioni
Con il suo rifiuto delle astrazioni universali, l’importanza del contesto storico e istituzionale e l’attenzione alle questioni sociali, la Scuola Storica Tedesca ha lasciato un’eredità intellettuale molto importante.
La sua concezione dell’economia non solo come scienza esatta, ma anche come strumento per comprendere la società e migliorarne le condizioni, continua a offrire spunti preziosi per un pensiero economico più realistico, critico e attento alla complessità del mondo contemporaneo.
La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:
1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone
2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone
3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica
4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno
5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti
6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica
7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo
8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito
9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say
10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi
11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero
12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico
13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier
14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero
15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale
16. Karl Marx: La teoria del valore
17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico
18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto
19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista
20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista
21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità
22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher
23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità
24. La Scuola Storica Tedesca di economia
25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale
26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano
27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico
28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta
29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises
32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione
33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità
34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia
35. Piero Sraffa
...