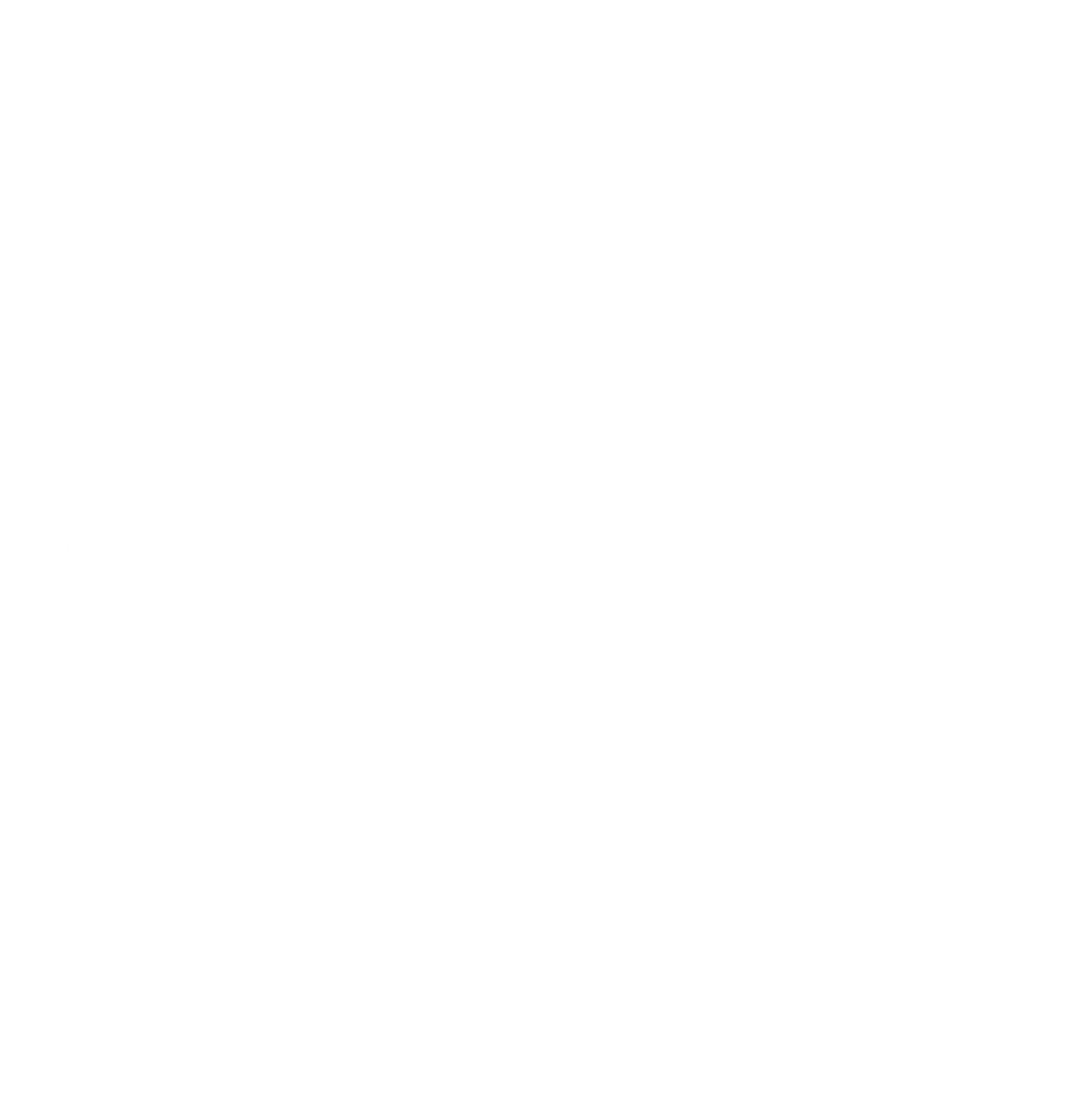10. Perché siamo altruisti? Le motivazioni nascoste dietro ai gesti di generosità
- Information
- Finanza comportamentale
- Prima pubblicazione: 27 Luglio 2025 Stampa
«L’avaro diventa ricco facendo mostra di essere povero, mentre il prodigo s’impoverisce facendo mostra di essere ricco».
William Shenstone
Siamo buoni per natura o agiamo correttamente solo quando qualcuno ci osserva?
Di fronte ad atti di generosità o di cooperazione, tendiamo a pensare che l’altruismo nasca da motivazioni pure e disinteressate.
Eppure, quando economia e psicologia analizzano questi comportamenti più da vicino, le ricerche sulle preferenze sociali delineano un quadro più complesso: le motivazioni alla base, infatti, possono essere molto diverse da quelle che appaiono a prima vista.
Questo articolo intende approfondire tali motivazioni, distinguendo tra le diverse tipologie di preferenze e presentando alcuni importanti esperimenti che hanno contribuito a fare luce sulla questione.
Indice
- Preferenze distributive e preferenze basate sulle intenzioni
- L'influenza dell'immagine sociale e dell’immagine di sé
- Il ruolo della comunicazione
- Critiche e implicazioni
1. Preferenze distributive e preferenze basate sulle intenzioni
Per comprendere il comportamento umano, è utile distinguere tra due categorie di preferenze: distributive e basate sulle intenzioni.
Le preferenze distributive si concentrano esclusivamente sui risultati finali: quante risorse o quanto denaro vengono assegnati a sé stessi e agli altri, senza considerare il processo attraverso cui questi risultati sono stati ottenuti.
Se una persona si preoccupa soltanto di massimizzare la somma complessiva o di garantire una certa equità nella distribuzione, le sue preferenze rientrano in questa categoria.
Ad esempio, se si trova a dover dividere 10 euro, potrebbe scegliere una divisione 5-5 perché la ritiene equa (quindi focalizzata sull’esito), oppure optare per un 10-0 che le assicuri il massimo guadagno, senza badare a come sia arrivata ad avere il potere di decidere.
Le preferenze basate sulle intenzioni, invece, tengono conto del modo in cui un risultato è stato raggiunto.
Un esempio semplice e divertente è quello di un ragazzo che trova due mele: tiene per sé quella più grande e offre all’amico quella più piccola. L’amico protesta, dicendo che al suo posto avrebbe fatto il contrario. Il primo amico, allora, ribatte: «appunto, io volevo la mela più grande e tu avresti voluto darmi proprio quella. Non abbiamo entrambi ottenuto quello che volevamo?».
Naturalmente, la lamentela dell’amico non riguarda tanto la dimensione della mela, quanto la sensazione di essere stato trattato in modo egoista. In questo caso, non conta solo l’esito (ricevere la mela più piccola), ma anche l’intenzione percepita dietro alla scelta.
Questo esempio mostra quanto sia rilevante la giustizia procedurale, ovvero la percezione di equità nei criteri utilizzati per distribuire risorse: si tratta di un fattore che spesso influisce profondamente sulla soddisfazione delle persone e sul loro comportamento.
Pensiamo a un caso pratico: un dipendente potrebbe accettare di non essere stato promosso, a patto che il processo di selezione sia stato trasparente e meritocratico. Se invece percepisse favoritismi, la stessa mancata promozione potrebbe generare forte frustrazione.
Un altro aspetto centrale delle preferenze basate sulle intenzioni è la reciprocità: la tendenza a trattare gli altri come loro hanno trattato noi.
Questo meccanismo può rafforzare sia comportamenti altruistici, sia reazioni ostili, a seconda delle circostanze.
2. L'influenza dell'immagine sociale e dell’immagine di sé

«Un grande errore è quello di credersi più di ciò che si è e stimarsi meno di ciò che si vale».
Goethe
Molti comportamenti che appaiono altruistici sono in realtà motivati dal desiderio di proteggere o valorizzare la propria immagine sociale – cioè come vogliamo essere visti dagli altri – oppure l’immagine che abbiamo di noi stessi, ovvero il nostro giudizio interiore.
Le persone possono quindi agire in modo generoso non tanto per un autentico interesse verso il benessere altrui, quanto per evitare di apparire egoiste o per continuare ad avere una buona opinione di sé stesse.
Ma come distinguere queste motivazioni da un altruismo genuino?
Diversi esperimenti hanno cercato di rispondere a questa domanda.
Per indagare queste spinte più profonde, i ricercatori hanno ideato versioni modificate del classico Dictator Game, un gioco in cui un “dittatore” decide come dividere una somma di denaro con un “ricevente”, che non ha alcun potere decisionale.
Abbiamo introdotto il Dictator Game nell'articolo precedente di questa serie: Altruismo, equità e fiducia nelle scelte individuali: da dove derivano questi comportamenti?
L’esperimento di Lazear, Malmendier e Weber: L’opzione di uscita
In questo studio è stata introdotta una variante del Dictator Game in cui il “dittatore” poteva scegliere se partecipare oppure no.
L’alternativa era uscire dal gioco e prendersi 10 euro, senza dover decidere nulla e senza che il ricevente venisse a sapere che c’era stata un’occasione per ricevere qualcosa.
Nel gioco standard, i partecipanti mostravano una certa generosità: in media, donavano il 20-25% della somma disponibile. Ma con l’aggiunta dell’opzione di uscita, il comportamento cambiava radicalmente.
Nel caso di un’uscita senza costo (costless exit), il dittatore poteva, alternativamente:
- Uscire dal gioco e tenere 10 euro.
- Partecipare al gioco e decidere liberamente come dividere i 10 euro (ad esempio, 5-5, 8-2, 10-0 e così via).
Sorprendentemente, molti sceglievano di uscire e tenere tutto per sé, evitando così di esporsi a un dilemma morale. In media, l’importo donato da chi restava nel gioco crollava da circa 1,87 euro a soli 0,58 euro.
Questo perché, uscendo, il dittatore evitava che il ricevente sapesse che c’era stata la possibilità di ricevere qualcosa: un modo per non sentirsi egoista o non essere giudicato tale.
Dal punto di vista delle preferenze puramente distributive, l’opzione di uscita non dovrebbe influenzare la scelta: chi vuole donare dovrebbe comunque partecipare, e per chi vuole tenere tutto per sé dovrebbe essere indifferente.
Ma uscire significa evitare che il ricevente sappia di essere stato escluso: una via per non essere giudicati (né giudicarsi) egoisti.
Anche quando l’uscita era costosa (costly exit), cioè comportava rinunciare a un euro e riceverne solo 9, molte persone la sceglievano comunque, pur di non affrontare la situazione emotivamente e socialmente scomoda di trattenere tutto sotto gli occhi dell’altro.
In sintesi, le persone vogliono il denaro, ma non vogliono apparire, né sentirsi, egoiste.
L'Esperimento di Andreoni e Bernheim: nascondersi dietro al computer
In un’altra variante del Dictator Game, Andreoni e Bernheim hanno esplorato come cambia il comportamento quando le persone possono appellarsi a una “scusa plausibile”.
Il gioco prevedeva che, in alcune prove, una scelta (ad esempio: 20 euro per il dittatore, 0 per il ricevente) potesse essere imposta casualmente da un computer con una certa probabilità p.
Il ricevente conosceva la probabilità p, ma non poteva sapere se, in quel caso specifico, la scelta era stata fatta dal computer o dal dittatore.
Teoricamente, chi si basa solo sul risultato finale (preferenze distributive) dovrebbe ignorare p: l’unica cosa che conta è se si ha il controllo oppure no.
E invece i risultati hanno mostrato un pattern opposto: all’aumentare di p, aumentava anche il numero di dittatori che sceglievano di dare 0.
Per esempio, con p = 0, solo il 30% dei dittatori sceglieva 20-0. Ma con p = 0,5, questa percentuale saliva al 70%.
In altre parole, quando c’è una possibilità credibile che “sia stato il computer”, i dittatori si sentono più liberi di scegliere egoisticamente senza assumersene la responsabilità morale.
Una variante particolarmente interessante è quella in cui il computer imponeva 19-1. In questo scenario, molti dittatori sceglievano proprio 19-1 — non 20-0 — proprio per potersi nascondere dietro l’idea che fosse stata una scelta imposta.
Ancora una volta, il comportamento viene modulato per proteggere l’immagine di noi che vogliamo dare agli altri.
L’esperimento di Dana, Weber e Xi Kuang: Lo spazio di manovra morale
Mentre i due studi precedenti si focalizzavano sull’immagine sociale, Dana, Weber e Xi Kuang hanno studiato il ruolo dell’immagine di sé.
In questo esperimento, i partecipanti dovevano scegliere tra due opzioni:
- Opzione A: 6 euro per sé, x per l’altro.
- Opzione B: 5 euro per sé, y per l’altro.
In una versione base, con x = 1 e y = 5 (cioè 6-1 contro 5-5), la grande maggioranza (74%) sceglieva l’opzione più equa, la B.
In un’altra variante, però, i valori di x e y erano inizialmente sconosciuti: ogni partecipante si trovava casualmente in uno dei due scenari possibili, con probabilità 50% ciascuno:
- Scenario 1 (conflitto morale): A = 6-1 (egoista), B = 5-5 (equa).
- Scenario 2 (nessun conflitto): A = 6-5 (migliore per entrambi), B = 5-1 (peggiore per entrambi).
Ai partecipanti veniva offerta la possibilità, gratuita, di scoprire in quale scenario si applicasse al loro caso. Sorprendentemente, il 44% sceglieva di non informarsi. Di questi, il 95% finiva poi per scegliere l’opzione A, presumibilmente per ottenere il massimo personale evitando di sapere se stavano agendo in modo egoista.
Questo comportamento è inspiegabile con le sole preferenze distributive: informarsi non aveva alcun costo.
Il motivo risiede nel desiderio di preservare un’idea positiva di sé stessi: restando nell’ignoranza, i partecipanti potevano auto-convincersi che la scelta egoista fosse giustificata.
In pratica, si creavano un “margine morale” (moral wiggle room), uno spazio ambiguo in cui proteggere il proprio giudizio interiore, pur scegliendo in modo egoista.
Il messaggio è chiaro: per molti, è preferibile non sapere, pur di non dover fare i conti con l’immagine che hanno di sé stessi.
3. Il ruolo della comunicazione
La comunicazione può influenzare il comportamento altruistico soprattutto quando entrano in gioco le preoccupazioni per l’immagine sociale.
Un esperimento condotto da Ellingsen e Johannesson ha modificato il Dictator Game consentendo ai riceventi di inviare messaggi anonimi ai dittatori dopo aver ricevuto la somma che questi avevano deciso di assegnare loro.
L’anticipazione di un possibile messaggio, che poteva essere sia positivo che negativo, ha aumentato la generosità media dal 25% al 34%.
I messaggi variavano da insulti, come Avido bastardo, a ringraziamenti calorosi, del tipo Non dimenticherò il tuo gesto, grazie di cuore.
L’idea alla base è che i dittatori, immaginando la possibilità di ricevere un commento sgradevole, venissero spinti a essere più generosi per evitare una forma di punizione sociale o per ottenere approvazione e lodi.
Tuttavia, l’effetto della comunicazione non è sempre così prevedibile: in un altro esperimento, questa volta nel contesto dell’Ultimatum Game (in cui il ricevente può rifiutare l’offerta, impedendo così la divisione del denaro), il dialogo tra i partecipanti prima della decisione non ha avuto un impatto positivo sulla generosità media: in alcuni casi, ha addirittura prodotto esiti peggiori.
Sono infatti emerse più frequentemente offerte nulle, che venivano poi rifiutate, suggerendo che la comunicazione possa talvolta degenerare in minacce o provocazioni invece che in un accordo: in questi casi, anziché facilitare la cooperazione, la possibilità di interagire può esacerbare i conflitti, portando i proponenti a risposte ostili.
Il risultato mette in luce la complessità delle dinamiche interpersonali, dove la parola può tanto favorire l’intesa quanto alimentare lo scontro.
In fondo, non scopriamo niente di nuovo: tutti sappiamo quanto le parole possano confortare o ferire. Il problema è che spesso perdiamo il controllo della scelta di ciò che diciamo, soprattutto quando sono le emozioni a guidarci.
4. Critiche e implicazioni
A prima vista, questi risultati potrebbero sembrare scoraggianti, perché suggeriscono che le persone sono meno generose di quanto sembri.
In realtà, offrono spunti preziosi. Capire che il comportamento altruistico è spesso influenzato dall’immagine sociale o dall’idea che abbiamo di noi stessi può aiutarci a capire meglio i contesti che favoriscono la cooperazione.
Questi studi non affermano che siamo irrimediabilmente egoisti, ma mostrano quanto siamo sensibili al contesto sociale e alle storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre azioni.
Distinguere tra altruismo genuino, desiderio di fare buona impressione e bisogno di mantenere una buona immagine di sé è fondamentale per capire come nasce la cooperazione.
Se riusciamo a capire quali fattori incoraggiano o ostacolano i comportamenti altruistici, come la visibilità delle azioni, la possibilità di eludere responsabilità morali o la presenza di un feedback sociale, potremo progettare contesti – nelle aziende e nella società – capaci di favorire relazioni più solidali.
Lo scopo della ricerca non è stabilire quanto le persone siano “buone”, ma comprendere perché si comportano in un certo modo e come creare le condizioni affinché l’altruismo possa manifestarsi, anche quando non nasce da motivazioni del tutto disinteressate.
La serie di articoli LEZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE contiene:
1. Che cos'è la finanza comportamentale: quando psicologia e finanza convergono
6. Preferenze di rischio 1. Il modello dell'utilità attesa tra teoria e realtà
7. Preferenze di rischio 2. La Prospect Theory (Teoria del prospetto)
8. Preferenze di rischio 3. Perché facciamo certe scelte? La Prospect Theory nella vita quotidiana
9. Preferenze sociali 1. Altruismo, equità e fiducia nelle scelte individuali
12. I limiti dell'attenzione e le loro conseguenze sulle scelte economiche
13. Perché crediamo a ciò che ci fa star meglio: l'utilità derivante dalle credenze
15. Default, nudge e frame: l'architettura delle scelte nelle decisioni finanziarie
16. Malleabilità delle preferenze: dalle scelte inconsapevoli ai nudge nelle politiche pubbliche