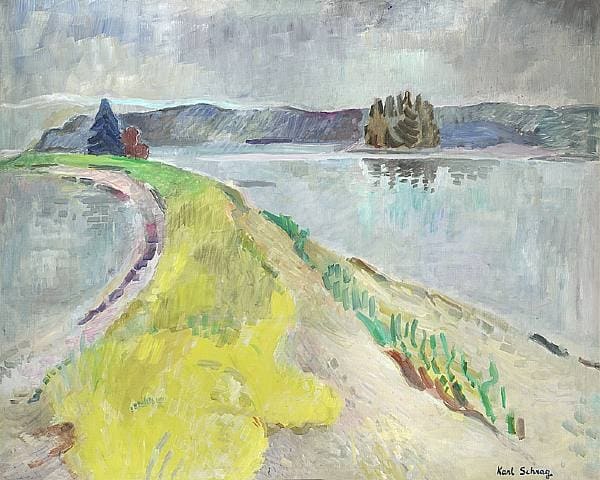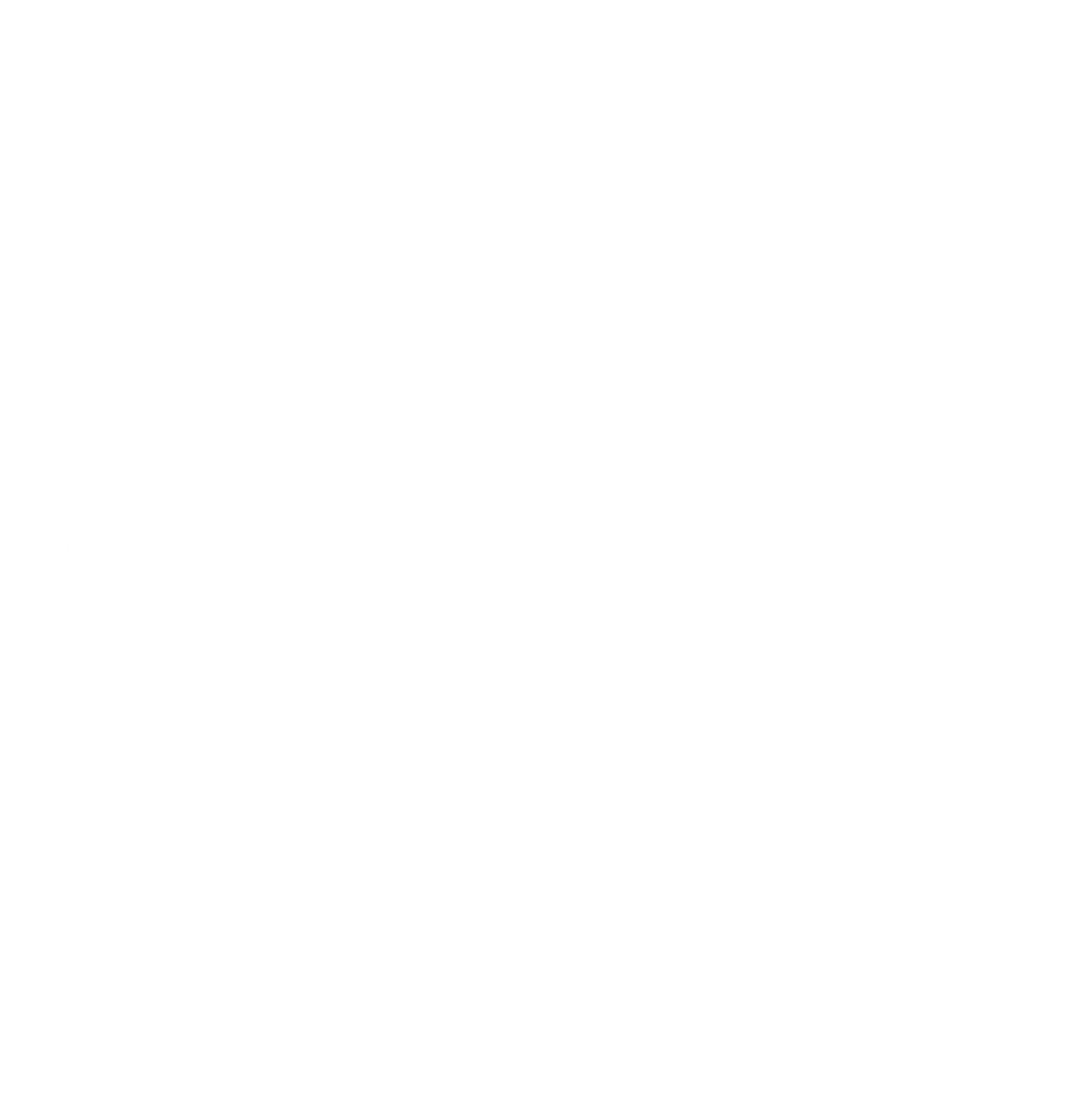14. Come gli stati d’animo e le condizioni fisiche influenzano le scelte: preferenze, projection bias e attribution bias
- Information
- Finanza comportamentale
- Prima pubblicazione: 19 Ottobre 2025
«È sempre in uno stato d’animo non destinato a durare che si prendono risoluzioni definitive».
Marcel Proust
Ogni scelta porta con sé l’idea che le preferenze personali siano stabili nel tempo, coerenti con i valori individuali e indipendenti dal contesto.
Eppure, una riflessione più attenta – e una crescente mole di evidenze empiriche – mostrano quanto questa convinzione sia illusoria.
Le nostre decisioni non nascono dal nulla: riflettono gli stati d’animo e le condizioni psicofisiche in cui ci troviamo al momento della scelta.
In questo articolo, analizzeremo come tali stati – dalla fame alla stanchezza, dal dolore al desiderio – modifichino sistematicamente le nostre preferenze, portandoci a errori di giudizio sia quando immaginiamo il futuro, sia quando interpretiamo il passato.
Indice
- Le preferenze dipendenti dallo stato psicofisico: come gli stati d’animo e le condizioni fisiche modellano le scelte
- Il projection bias (bias di proiezione): teoria, esperimenti e modelli di previsione
- Dalle distorsioni individuali alle implicazioni collettive: proiezione, dipendenza e politiche pubbliche
- L'attribution bias (bias di attribuzione)
- Conclusioni
1. Le preferenze dipendenti dallo stato psicofisico: come gli stati d’animo e le condizioni fisiche modellano le scelte
Sebbene l’economia tradizionale abbia raramente posto l’accento su questo aspetto, è assodato che le nostre preferenze cambino nel tempo.
Queste variazioni possono essere classificate in tre categorie:
- Fluttuazioni a breve termine (preferenze dipendenti dallo stato psicofisico). Si tratta di cambiamenti temporanei e reversibili, legati a stati fisiologici o psicologici immediati. Lo “stato”, in questo caso, è una condizione di breve durata come la fame, la sete, il dolore o l’umore. È intuitivo che una persona affamata desideri cose diverse rispetto a una persona sazia; tuttavia, la difficoltà nel prevedere questi cambiamenti è proprio ciò che li rende interessanti dal punto di vista economico e comportamentale.
- Cambiamenti sistematici a lungo termine. Questi possono derivare da scelte individuali, come nel caso della dipendenza da fumo o alcol, oppure da fattori indipendenti dalle nostre decisioni, come l’invecchiamento. Ad esempio, una persona dipendente da dieci anni dall'alcol trae un’utilità dal suo consumo molto diversa rispetto a chi non l'ha mai bevuto. Fenomeni come la dipendenza mostrano, quindi, sia fluttuazioni a breve termine (il desiderio di una sigaretta subito dopo averne fumata una) sia cambiamenti sistematici di lungo periodo.
- Adattamento ai cambiamenti. Riguarda il modo in cui le nostre preferenze o il livello di felicità si adattano a grandi trasformazioni della vita, come il mutamento del tenore di vita, o a variazioni più modeste, come il possesso di un oggetto specifico. È noto, ad esempio, che i vincitori della lotteria sperimentano un aumento immediato della felicità, che però tende a ridursi gradualmente fino a tornare al livello precedente.
In questa analisi, ci concentreremo soprattutto sulla prima categoria: le fluttuazioni temporanee e di breve durata.
Per comprendere come i nostri stati d’animo e le nostre condizioni fisiche influenzano le scelte, possiamo considerare alcuni esempi reali e sperimentali.
L’impatto della fame: l’esperimento del Minnesota
Studiare la fame presenta difficoltà etiche difficilmente superabili. Eppure, il celebre esperimento sulla fame del Minnesota (Minnesota Starvation Experiment), condotto per aiutare la riabilitazione dei soldati denutriti dopo la Seconda guerra mondiale, ha fornito risultati molto importanti.
I volontari, sottoposti a una drastica restrizione calorica, mostravano comportamenti estremi:
- Focalizzazione sul cibo: sviluppavano un’ossessione per il cibo, i pasti e perfino per argomenti collegati alla nutrizione.
- Apatia generale: perdevano interesse per quasi tutte le altre attività.
- Cambiamenti nelle preferenze di acquisto: oltre a un interesse “razionale” per gli articoli legati al cibo, si osservavano comportamenti meno logici, come l’acquisto di oggetti inutili o di poco valore – libri vecchi, vestiti usati, cianfrusaglie – spesso a costo di sacrifici economici. In seguito, molti partecipanti si chiedevano perché avessero fatto tali acquisti, evidenziando un’inversione delle preferenze.
Un esempio quotidiano dello stesso fenomeno è fare la spesa a stomaco vuoto. Come suggerisce il senso comune – e conferma la ricerca, tra cui lo studio di Nisbett e Kanouse – fare la spesa quando si ha fame porta ad acquistare di più, e in particolare più junk food.
In un esperimento, ai partecipanti veniva chiesto di mangiare o meno una barretta di cioccolato prima di entrare in un supermercato: chi non l’aveva mangiata, e quindi aveva più fame, tendeva ad acquistare più prodotti in generale (non solo per soddisfare la fame immediata) e prediligeva cibi meno salutari.
I partecipanti che avevano fame, ad esempio, compravano più tortilla chips, formaggi e bevande zuccherate, mentre quelli sazi optavano per alimenti più salutari come insalata e bevande ipocaloriche.
Sonno e autocontrollo
Anche la privazione del sonno modifica il nostro stato interno e, di conseguenza, le preferenze, alterando la percezione del mondo.
La stanchezza riduce l’autocontrollo: pur esistendo dibattiti sulla teoria che lo descrive come un “muscolo” che si ricarica durante il riposo, il legame tra mancanza di sonno e scarso autocontrollo è ampiamente documentato.
Gli effetti includono aumento di peso, una maggiore propensione a perdere tempo online e comportamenti meno etici: le persone stanche tendono, ad esempio, a imbrogliare più facilmente.
Alcuni studi suggeriscono persino che i sonnellini brevi possono avere effetti positivi, aumentando la propensione al risparmio e riducendo il present bias, cioè la preferenza per le ricompense immediate.
Dipendenza e volontà di pagare
In uno studio su 13 soggetti in recupero dalla dipendenza da eroina, Badger e altri autori misurarono la disponibilità a pagare (Willingness To Pay o WTP) per una seconda dose di buprenorfina (un farmaco usato come sostituto dell’eroina nei programmi di terapia sostitutiva).
L’esperimento confrontava due condizioni, una di deprivazione e una di sazietà:
- Condizione di astinenza: la domanda sulla disponibilità a pagare veniva posta due ore prima della dose programmata, quando i soggetti si trovavano in uno stato di astinenza.
- Condizione di post-somministrazione: la stessa domanda veniva posta subito dopo la prima dose, quando l'astinenza risultava notevolmente attenuata.
Poiché la seconda dose era prevista per un momento futuro (nello stesso giorno o nella settimana successiva), la disponibilità a pagare non avrebbe dovuto dipendere dallo stato in cui i soggetti si trovavano al momento della richiesta.
Tuttavia, i risultati mostrarono che la disponibilità a pagare variava sistematicamente in funzione dello stato attuale.
Per una dose prevista più tardi nello stesso giorno, la disponibilità mediana era di 75 dollari tra i soggetti in condizione di astinenza, contro 50 dollari tra quelli in condizione di post-somministrazione. Per una dose prevista la settimana successiva, la disponibilità era rispettivamente di 60 e 35 dollari.
In pratica, quando i partecipanti si trovavano in astinenza, tendevano a proiettare nel futuro il forte bisogno provato nel presente, sovrastimando quanto avrebbero desiderato la dose aggiuntiva anche una volta attenuati i sintomi dell’astinenza: non riuscivano a prevedere che, una volta soddisfatta la necessità immediata, la loro disponibilità a pagare sarebbe diminuita.
Dolore e dilemmi etici
Thomas Schelling discusse il tema dell’uso dell’anestesia durante il parto, un caso emblematico di rovesciamento delle preferenze:
- Ex ante (prima del dolore): molte donne preferiscono evitare l’anestesia.
- Durante il dolore: richiedono immediatamente l’anestesia al medico.
- Ex post (dopo il parto): alcune rimpiangono la decisione e avrebbero voluto non riceverla.
Questo schema, osservato anche tra donne che avevano già vissuto il parto, solleva dilemmi etici e legali: il medico deve decidere se rispettare la preferenza espressa prima del dolore o quella manifestata durante il travaglio.
L'elemento critico è l’errore di previsione delle preferenze in assenza di dolore: chi non si trova in uno stato di sofferenza tende a non anticipare correttamente le proprie scelte quando il dolore sarà presente.
2. Il projection bias (bias di proiezione): teoria, esperimenti e modelli di previsione
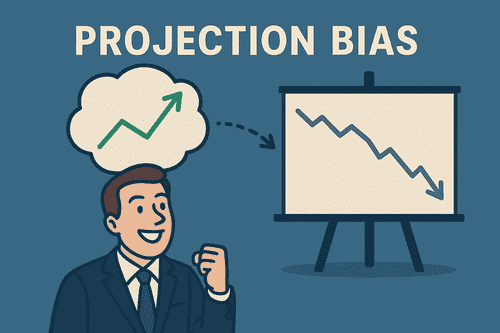
Tutti gli esempi precedenti conducono alla definizione del projection bias.
Questo bias si manifesta quando le persone sottovalutano i cambiamenti nelle proprie preferenze, proiettando i gusti e gli stati d’animo presenti su quelli futuri. Non si tratta di un errore di previsione casuale, ma di un errore sistematico.
Gli individui tendono a cogliere la direzione del cambiamento (ad esempio, comprendono che da sazi desidereranno acquistare meno patatine), ma ne sottostimano l’entità.
Una delle prove più solide a sostegno del projection bias è che esso persiste anche in situazioni di esperienza quotidiana e ripetuta, come la sensazione di fame: non può quindi essere attribuito a una semplice mancanza di esperienza come accade, per esempio, per il dolore fisico intenso o per il parto.
Questo suggerisce che si tratti di un bias cognitivo profondo, che rende difficile immaginare come ci si sentirà quando l’influenza di stati fisiologici, come la fame, l'astinenza o il dolore, non sarà più presente.
Lo studio di Read e van Leeuwen
Lo studio di Read e van Leeuwen, originariamente condotto per analizzare il present bias, può essere reinterpretato anche in chiave di projection bias.
Nell’esperimento, gli impiegati dovevano scegliere uno snack che avrebbero ricevuto la settimana successiva. Al momento della scelta, alcuni partecipanti si trovavano in uno stato di fame (nel tardo pomeriggio), altri in una condizione di sazietà (subito dopo pranzo).
A ciascuno veniva poi chiesto di immaginare il proprio stato futuro, ossia se al momento della ricezione dello snack avrebbe avuto fame o sarebbe stato sazio. In questo modo, i ricercatori potevano confrontare le scelte effettuate da persone affamate o sazie che immaginavano stati futuri diversi.
Se i partecipanti avessero previsto correttamente le proprie preferenze, le scelte avrebbero dovuto dipendere solo dallo stato futuro immaginato, non da quello presente.
I risultati, tuttavia, mostrarono che lo stato attuale influenzava sistematicamente le decisioni, evidenziando come la fame o la sazietà del momento alterino la capacità di anticipare le preferenze future.
I risultati possono essere riassunti nella seguente tabella:
| Stato al momento della scelta (oggi) | Fame prevista (settimana successiva) | Sazietà prevista (settimana successiva) |
| Fame oggi | 78% | 42% |
| Sazietà oggi | 56% | 26% |
Le percentuali indicano la quota di partecipanti che ha scelto uno snack poco salutare. Le percentuali sulla diagonale principale (78% e 26%) rappresentano le scelte coerenti, cioè quelle in cui lo stato presente e quello futuro coincidono.
Quando lo stato previsto e quello reale divergono, emergono invece deviazioni che rivelano il projection bias.
Chi sceglieva in preda alla fame per un momento futuro di sazietà tendeva a sovrastimare quanto avrebbe desiderato cibi calorici, scegliendo snack poco salutari nel 42% dei casi (invece del 26% atteso).
Viceversa, chi sceglieva da sazio per un momento futuro di fame sottovalutava l’effetto della fame futura, scegliendo snack non salutari nel 56% dei casi (invece del 78% atteso).
In entrambi i casi, i partecipanti prevedevano correttamente la direzione del cambiamento (sapendo che la fame o la sazietà avrebbero modificato le preferenze), ma sottostimavano l’entità di tale cambiamento.
Questa distorsione è il tratto distintivo del projection bias: lo stato presente “contamina” la previsione dello stato futuro.
Altri esempi di projection bias
Acquisti di articoli per il freddo (Conlin e altri autori)
Chi acquista un giubbotto in una giornata insolitamente fredda tende a proiettare il bisogno attuale sul futuro.
La conferma del projection bias non deriva solo dall’aumento delle vendite, che potrebbe essere spiegato dal maggior impatto del freddo, ma dal fatto che la probabilità di restituzione del capo è più alta se l’acquisto è avvenuto in una giornata particolarmente rigida.
Il consumatore, in altre parole, si comporta come se il futuro fosse composto solo da giornate gelide.
Acquisti di automobili (Busse e altri autori)
Le persone comprano più cabriolet nei giorni di sole e più veicoli a trazione integrale (4×4) nei giorni di maltempo.
Se questo comportamento fosse dovuto soltanto a una maggiore attenzione momentanea alle condizioni meteorologiche, non potremmo parlare di un bias.
Diventa invece projection bias perché gli acquirenti tendono a restituire la cabriolet comprata in una giornata soleggiata quando arriva il maltempo, e il 4×4 acquistato in una giornata nevosa quando torna il bel tempo.
Critiche e Implicazioni di Mercato
Non sempre è facile distinguere se un errore di previsione derivi da una cattiva anticipazione delle proprie preferenze future o da una scorretta previsione delle condizioni esterne.
Ad esempio, un individuo può sopravvalutare quanto gli piacerà guidare una cabriolet non solo perché non riesce a immaginarsi annoiato di stare alla guida, ma anche perché non prevede che le condizioni meteo potrebbero cambiare.
Dal punto di vista del mercato, le imprese possono sfruttare il projection bias vendendo prodotti nei momenti in cui la disponibilità a pagare è più alta (ad esempio, cabriolet nei giorni di sole). Devono però fare molta attenzione: se i resi sono facili, la strategia può rivelarsi inefficiente, poiché i consumatori tendono a correggere rapidamente le proprie scelte quando cambia lo stato d'animo o variano le condizioni esterne.
Per formalizzare il concetto di projection bias, Loewenstein e altri autori hanno proposto un modello in cui l’utilità effettiva al tempo \( t \), indicata con \( u \), dipende sia dal consumo \( c_{t} \) sia dallo stato interno \( s_{t} \) (ad esempio il livello di fame, di dipendenza o di stanchezza).
L’utilità futura, al tempo \( \tau > t \), è quindi:
\begin{equation}
u(c_{\tau}, s_{\tau})
\end{equation}
Tuttavia, al tempo \( t \), l’individuo deve prevedere tale utilità futura. La previsione, indicata con \( \hat{u} \), è espressa come:
\begin{equation}
\hat{u}(c_{\tau}, s_{\tau}) = (1 - \alpha) \cdot u(c_{\tau}, s_{\tau}) + \alpha \cdot u(c_{\tau}, s_{t})
\end{equation}
Dove:
- \( u(c_{\tau}, s_{\tau}) \) è l’utilità futura reale, calcolata sullo stato effettivo futuro.
- \( \hat{u}(c_{\tau}, s_{\tau}) \) è l’utilità stimata, calcolata usando lo stato attuale invece di quello futuro;
- \( \alpha \in [0, 1] \) rappresenta il grado di projection bias.
In particolare:
- se \( \alpha = 0 \), non esiste projection bias (le aspettative sono pienamente razionali);
- se \( \alpha = 1 \), l’individuo proietta completamente il proprio stato attuale, credendo che in futuro sarà identico a quello presente.
Esempio numerico
Supponiamo che l’utilità \( u \) di una persona dipenda dal consumo di hamburger \( b \) e dal denaro disponibile \( m \), e che essa vari a seconda dello stato in cui si trova: fame (H) o sazietà (N).
La funzione di utilità può essere espressa in forma lineare come:
\begin{equation}
u(b, m) = β \cdot b + m
\end{equation}
dove il coefficiente β rappresenta il valore soggettivo attribuito a un’unità del bene, ossia la disponibilità a pagare per un hamburger.
Nello stato di sazietà (N):
\begin{equation}
u(b, m) = 1 \cdot b + m
\end{equation}
La disponibilità a pagare è pari a 1.
Nello stato di fame (H):
\begin{equation}
u(b, m) = 5 \cdot b + m
\end{equation}
La disponibilità a pagare sale a 5.
Ora immaginiamo che una persona, attualmente sazia, debba prevedere la propria disponibilità a pagare per un hamburger più tardi, quando sarà affamata.
In base al modello di projection bias, l’individuo tende a proiettare parzialmente il suo stato presente sul futuro.
Se il grado di distorsione è pari a \( \alpha = \tfrac{3}{4} \), la disponibilità a pagare (la abbreviamo in WTP, willingness to pay) prevista risulterà:
\begin{equation}
WTP_{\text{prevista}} = (1 - \alpha) \cdot WTP_{\text{futura}} + \alpha \cdot WTP_{\text{attuale}}
\end{equation}
\begin{equation}
WTP_{\text{prevista}} = (1 - \tfrac{3}{4}) \cdot 5 + \tfrac{3}{4} \cdot 1 = \tfrac{1}{4} \cdot 5 + \tfrac{3}{4} \cdot 1 = 1,25 + 0,75 = 2
\end{equation}
L’individuo sazio proietta il proprio stato attuale per tre quarti, stimando erroneamente che la propria disponibilità a pagare futura sarà pari a 2, invece del valore reale di 5.
In altri termini, la persona sazia riconosce che in futuro attribuirà all’hamburger un valore più alto, ma incorpora solo un quarto del cambiamento totale di preferenza (pari a 4), sottovalutando sistematicamente l’impatto della fame sul valore percepito dell’hamburger.
3. Dalle distorsioni individuali alle implicazioni collettive: proiezione, dipendenza e politiche pubbliche
Sebbene le conseguenze del projection bias su scelte minori — come l’acquisto di un’auto o di un articolo di consumo — siano spesso reversibili e limitate, le sue implicazioni in contesti più importanti possono essere profonde e persino pericolose.
Di seguito analizziamo tre ambiti in cui questo bias rivela tutta la sua forza: la dipendenza, la depressione e la sottostima dell’adattamento.
A. Dipendenza e Cicli di astinenza
Il projection bias è un meccanismo chiave per comprendere sia l’origine che la persistenza della dipendenza.
Una persona non ancora dipendente – che si trova, cioè, in uno stato di astinenza bassa o assente – può credere che sperimentare una sostanza sia innocuo o facilmente controllabile, proiettando nel futuro le proprie preferenze attuali, in cui resistere è semplice.
Da ciò nasce una falsa sensazione di controllo: la convinzione che smettere sarà sempre possibile, ignorando che, con l’intensificarsi dell’astinenza, resistere diventerà progressivamente più difficile.
Il projection bias contribuisce anche a spiegare i cicli di astinenza e ricaduta tipici dei comportamenti di dipendenza.
Inizio dell'astinenza
Dopo un consumo recente, i sintomi di astinenza sono lievi. L’individuo, proiettando questo stato nel futuro, crede che resistere sarà sempre facile e decide di smettere.
Abbandono del tentativo
Col passare del tempo o in presenza di un cue (come un luogo, un odore o una persona associati alla sostanza), l’astinenza si intensifica. L’individuo, proiettando questa sensazione sul futuro, conclude che resistere sarà sempre impossibile e abbandona il tentativo, ritenendolo inutile.
Il projection bias aiuta anche a spiegare le ricadute: chi sottovaluta l’effetto dei cue esterni – come un bar, un gruppo di amici o un profumo legato al consumo – si espone inconsapevolmente a situazioni rischiose.
In tali circostanze, fallisce nel resistere e ricade nel comportamento dipendente, perché aveva previsto di essere meno vulnerabile di quanto non sia realmente.
B. Depressione e speranza
Le persone in stato depressivo tendono a proiettare i propri sentimenti non solo verso il futuro, ma anche verso il passato.
La depressione è stata spesso descritta come “l’incapacità di costruire un futuro”: chi ne soffre si sente intrappolato nel presente, incapace di ricordare di essere stato meglio in passato o di immaginare un miglioramento in futuro.
Questa proiezione estrema della sofferenza altera la percezione del tempo e delle possibilità, generando una profonda mancanza di speranza. Il soggetto arriva così a credere che la vita sia sempre stata, e sarà sempre, dolorosa.
Tale errore di previsione dello stato emotivo ha conseguenze potenzialmente gravi: chi ne è vittima può rinunciare a cercare aiuto o trattamento, convinto che la propria condizione non potrà mai cambiare.
In questo senso, la depressione rappresenta una forma estrema di projection bias, in cui l’incapacità di immaginare stati emotivi diversi perpetua il disagio stesso.
C. Sottostima dell’adattamento (immune neglect)
Il projection bias si manifesta anche nel lungo periodo, quando le persone sottovalutano la propria capacità di adattamento psicologico: un fenomeno noto come immune neglect, descritto da Gilbert e altri autori.
Quando si cerca di prevedere l’impatto emotivo di eventi importanti, positivi o negativi, la previsione affettiva tende a essere distorta: stimiamo correttamente la direzione della reazione, ma ne sovrastimiamo la durata e l’intensità.
Eventi negativi
Dopo uno shock avverso – come non ottenere una promozione o vivere una perdita importante – le persone tendono a credere che la loro vita resterà irrimediabilmente compromessa.
L’impatto iniziale, effettivamente doloroso, è previsto in modo preciso, ma l’effetto a lungo termine risulta molto meno pesante: nel tempo, la maggior parte delle persone si adatta e ritorna a livelli di benessere simili a quelli precedenti.
Eventi positivi
Anche in presenza di successi o ricompense eccezionali, come una vincita alla lotteria, si osserva lo stesso errore di previsione. Le persone sottostimano la rapidità e la completezza dell’adattamento emotivo, credendo che la felicità derivante dall’evento durerà per sempre.
In entrambi i casi, il meccanismo di fondo è lo stesso: l’individuo proietta il proprio stato emotivo attuale nel futuro, ignorando la naturale tendenza dell’equilibrio psicologico a ripristinarsi nel tempo.
Projection bias e sconto quasi-iperbolico ingenuo
Sia il projection bias che lo sconto quasi-iperbolico ingenuo (naive quasi-hyperbolic discounting) implicano un errore di previsione del sé futuro.
In alcuni casi, possono perfino spiegare lo stesso comportamento, come ad esempio il fallimento di un fumatore nel tentativo di smettere.
Naive quasi-hyperbolic discounting
Il fumatore ingenuo sovrastima la propria pazienza futura e sottovaluta i problemi di autocontrollo (present bias). Per questo, si auto-impone un vincolo – ad esempio, decide di smettere, fissa una data o si iscrive a un programma di supporto – che, tuttavia, si rivela insufficiente a contenere la sua futura impulsività.
Projection bias
Il fumatore, trovandosi in uno stato di astinenza bassa, sottostima quanto i futuri stati di forte desiderio influenzeranno le sue preferenze. Anche in questo caso si auto-impone un vincolo troppo debole, poiché non riesce a prevedere quanto difficile sarà resistere quando la crisi di astinenza si intensificherà.
La chiave per distinguerli sta nella dipendenza dallo stato:
- Il projection bias è un errore di previsione dipendente dallo stato psicofisico, che si manifesta quando lo stato attuale è diverso da quello futuro (ad esempio, una persona sazia che decide per quando sarà affamata).
- Il present bias è invece una distorsione temporale, non legata allo stato, che riflette una preferenza generale per ricompense immediate.
Questa distinzione ha importanti implicazioni per le politiche pubbliche. Per rendere efficaci i dispositivi di impegno (commitment devices), è opportuno proporli quando le persone si trovano nello stesso stato per cui stanno pianificando le proprie decisioni future: ad esempio, offrire programmi di sostegno allo smettere di fumare nei momenti in cui l’astinenza è più intensa.
In queste condizioni, la percezione dell’utilità futura è più realistica e le scelte risultano più coerenti con i bisogni del sé futuro.
4. L'Attribution bias (bias di attribuzione)
L'attribution bias è un concetto affine al projection bias, ma con una direzione temporale opposta: mentre quest’ultimo riguarda la previsione delle preferenze future, l'attribution bias riguarda la valutazione delle esperienze passate.
L’errore consiste nel sovrastimare l’influenza dello stato in cui ci si trovava al momento del consumo. Quando si valuta un bene o un’esperienza, si tende cioè ad attribuire la qualità percepita alle caratteristiche oggettive del bene, invece che allo stato fisico o emotivo, temporaneo, in cui ci si trovava.
Esempi comuni:
- Ristorante: si è più propensi a tornare in un ristorante se la prima visita è avvenuta quando avevamo molta fame, quindi il cibo poteva sembrare straordinario, anche se la qualità oggettiva non era eccezionale.
- Film: un film può essere giudicato negativamente se lo si è visto in un momento di stanchezza, quando in realtà l’esperienza mediocre deriva dalla fatica, non dal valore dell’opera.
- Zoo o lezione: si può sconsigliare la visita di uno zoo perché durante la precedente esperienza pioveva, o ritenere una lezione noiosa solo perché la si è seguita in un momento di stanchezza. In entrambi i casi, si confonde lo stato personale con la qualità dell’esperienza.
Il projection bias e l'attribution bias rappresentano due facce complementari dello stesso problema: la difficoltà della mente umana nel separare gli stati soggettivi dalle valutazioni oggettive.
Il primo agisce verso il futuro, alterando le previsioni sulle preferenze che avremo; il secondo opera verso il passato, distorcendo il ricordo e la valutazione di esperienze già vissute.
Entrambi generano errori sistematici di giudizio, con implicazioni profonde nei comportamenti quotidiani e, in casi come la dipendenza o la depressione, conseguenze che possono essere durature e difficili da correggere.
5. Conclusioni
L’analisi dei bias legati agli stati psicofisici mette in luce un aspetto fondamentale della razionalità umana: le preferenze non esistono mai in astratto, ma si formano e si trasformano in relazione alle condizioni fisiche ed emotive dell’individuo.
Questa consapevolezza sposta l’attenzione dal mito della coerenza decisionale all’immagine più realistica di un soggetto che, pur agendo in modo intenzionale, non dispone mai di un accesso neutro alle proprie preferenze.
Riconoscere la natura dinamica e condizionata delle scelte non significa negare la razionalità, ma intenderla in modo più profondo: come un processo che prende forma nel corpo, nelle emozioni e nel tempo.
In questa prospettiva, le politiche pubbliche e gli strumenti economici dovrebbero mirare non tanto a “correggere” i comportamenti individuali, quanto a creare contesti decisionali più compatibili con la variabilità umana: contesti che tengano conto del modo in cui gli stati d’animo e le condizioni fisiche influenzano, spesso in modo silenzioso, le nostre decisioni.
La serie di articoli LEZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE contiene:
1. Che cos'è la finanza comportamentale: quando psicologia e finanza convergono
6. Preferenze di rischio 1. Il modello dell'utilità attesa tra teoria e realtà
7. Preferenze di rischio 2. La Prospect Theory (Teoria del prospetto)
8. Preferenze di rischio 3. Perché facciamo certe scelte? La Prospect Theory nella vita quotidiana
9. Preferenze sociali 1. Altruismo, equità e fiducia nelle scelte individuali
12. I limiti dell'attenzione e le loro conseguenze sulle scelte economiche
13. Perché crediamo a ciò che ci fa star meglio: l'utilità derivante dalle credenze
15. Default, nudge e frame: l'architettura delle scelte nelle decisioni finanziarie
16. Malleabilità delle preferenze: dalle scelte inconsapevoli ai nudge nelle politiche pubbliche