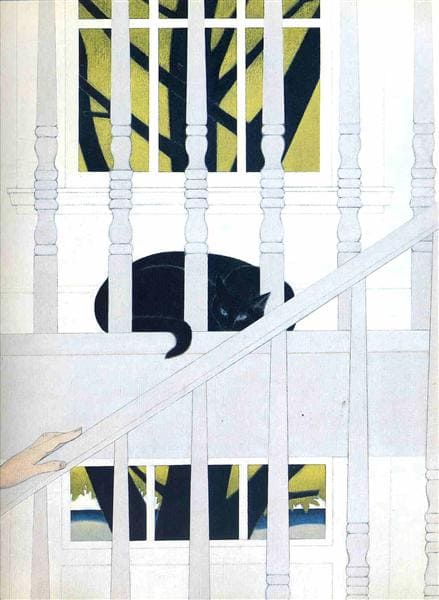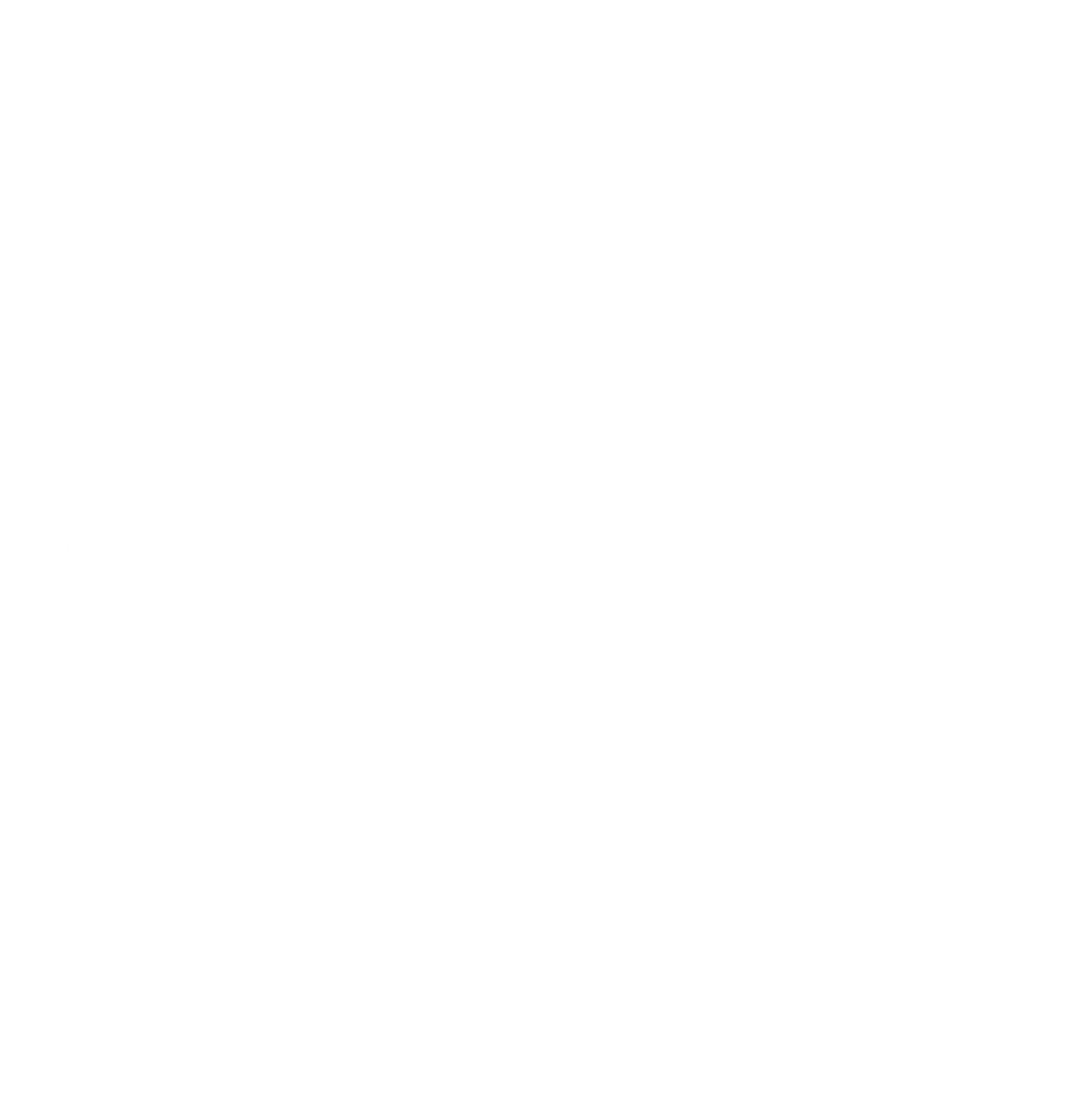13. Perché crediamo a ciò che ci fa stare meglio: l’utilità derivante dalle credenze
- Information
- Finanza comportamentale
- Prima pubblicazione: 28 Settembre 2025
«Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità».
Friedrich Nietzsche
In economia, la soddisfazione o il benessere degli individui – l’utilità – è stata tradizionalmente collegata a risultati concreti come il denaro, i beni di consumo o la salute: questi elementi sono stati per lungo tempo considerati i principali fattori della funzione di utilità.
Negli ultimi anni, però, una nuova corrente della finanza comportamentale ha proposto un’idea innovativa: l’utilità può derivare direttamente dalle credenze che le persone nutrono riguardo ai possibili risultati delle proprie azioni, al mondo che le circonda, a sé stesse o al proprio futuro.
Questo approccio si discosta nettamente dall’assunto neoclassico secondo cui le credenze sarebbero sempre frutto di informazioni perfette.
L’idea di fondo è che ciò che pensiamo di noi stessi, delle nostre capacità (come il livello di intelligenza), degli eventi futuri (ad esempio una vacanza imminente) o delle circostanze attuali, possa incidere sul nostro benessere immediato.
In altre parole, la felicità dipende non solo da ciò che possediamo o viviamo, ma anche dall’anticipazione e dalla percezione di questi elementi.
Un esempio potrebbe essere la preparazione a un discorso pubblico importante: sebbene l’esperienza stessa possa generare utilità (positiva o negativa), lo stress e l’attesa che la precedono possono superare l’impatto dell’evento in sé. Nei giorni che lo precedono, si può provare eccitazione o ansia, sperimentando così una vera e propria utilità o disutilità anticipatoria.
Inoltre, l’utilità derivante dalle credenze può persino generare degli effetti concreti sul corpo umano: lo dimostrano gli studi sugli effetti placebo, dove la semplice convinzione di ricevere una cura efficace può produrre miglioramenti clinici reali, anche senza un principio attivo.
Indice
- Anticipazione ed ego: i due volti dell’utilità derivante dalle credenze
- Informazione e compromessi: come le credenze influenzano le nostre scelte
- Critiche e punti di forza di un ottimismo eccessivo
- Euristiche e bias: quando la mente ci inganna
- Come le politiche pubbliche possono orientare le scelte collettive e il benessere
1. Anticipazione ed ego: i due volti dell’utilità derivante dalle credenze
Il concetto di utilità derivante dalle credenze si manifesta principalmente in due forme interconnesse: l’utilità anticipatoria e quella legata all’ego.
Utilità anticipatoria
Questa forma di utilità nasce dall’attesa di eventi futuri, positivi o negativi. È il piacere o il disagio che proviamo nel presente semplicemente pensando a ciò che potrebbe accadere.
Molte emozioni umane, come la speranza, la paura, l’ansia o il piacere dell’attesa (savoring), sono profondamente legate a ciò che immaginiamo per il futuro: si può provare ansia per un evento improbabile o assaporare con gioia l’idea di qualcosa di bello in arrivo.
L’utilità anticipatoria influenza concretamente i comportamenti, soprattutto nella scelta del momento in cui vivere certe esperienze e nell’acquisizione di informazioni.
Un aspetto interessante riguarda la scelta del momento in cui vivere un’esperienza piacevole. Quando abbiamo la possibilità di decidere, spesso preferiamo posticipare l’evento per prolungare il piacere dell’attesa.
Ad esempio, programmare una vacanza tra sei mesi può risultare più desiderabile rispetto a una vacanza imminente, proprio perché offre un periodo più lungo di aspettativa positiva. Tuttavia, questa scelta va bilanciata con lo sconto temporale, che tende a farci preferire gratificazioni immediate piuttosto che lontane nel tempo.
L’interazione tra queste due forze può produrre una curva di valutazione a forma di “U invertita”, suggerendo che esiste un ritardo ottimale, ma non eccessivo, per esperienze positive.
Vediamo un esempio pratico: immaginiamo che una vacanza, se vissuta domani, valga 100 “unità di felicità” grazie alla soddisfazione immediata. Ma se la vacanza viene programmata tra sei mesi (180 giorni), il piacere legato all’attesa può aggiungere 0,2 unità di felicità per ogni giorno di attesa, per un totale di 36 unità (180 × 0,2).
C’è però un aspetto importante: quanto più la vacanza è lontana nel tempo, tanto meno il suo valore viene percepito oggi, a causa di quello che in economia si chiama “sconto temporale”: in pratica, i 100 che la vacanza varrebbe se fosse domani, tra sei mesi possono essere percepiti come 70 unità, perché la gratificazione non è immediata.
Il totale sarà quindi dato dalla somma tra il piacere dell’attesa (36) e il valore “scontato” della vacanza (70), per un risultato complessivo di 106 unità di felicità.
Se invece la vacanza fosse tra dieci anni, lo sconto sarebbe così elevato da annullare la felicità della vacanza stessa, rendendo inutile l’attesa prolungata.
Per esperienze spiacevoli – come una scossa elettrica o, come proposto da George Loewenstein nel suo studio, la pulizia di gabbie di criceti – le persone tendono invece a volerle affrontare subito, eliminando così il periodo di anticipazione negativa.
Questa tendenza contrasta con lo sconto temporale, che normalmente porterebbe a posticipare ciò che è sgradevole. Gli esperimenti di Loewenstein mostrano in modo chiaro queste dinamiche.
Utilità dell’ego
Questo tipo di utilità deriva dal piacere che le persone provano nel mantenere una visione positiva di sé stesse: la convinzione di essere intelligenti, capaci o di maggior valore rispetto agli altri genera benessere immediato.
L’utilità dell’ego spiega perché spesso tendiamo a sovrastimare le nostre capacità, a ignorare informazioni negative o a giustificare errori, tutto pur di difendere la nostra autopercezione.
Questa tendenza può portarci a interpretare successi e insuccessi in modo da proteggere l’immagine che abbiamo di noi stessi, anche a costo di distorcere la realtà.
L’utilità dell’ego riflette il valore psicologico che attribuiamo alle convinzioni favorevoli su noi stessi, anche quando non sono del tutto realistiche.
Sia l’utilità anticipatoria che quella dell’ego possono portare le persone a coltivare illusioni positive: credere che le cose vadano meglio di quanto non siano in realtà può aumentare la felicità nel breve termine.
2. Informazione e compromessi: come le credenze influenzano le nostre scelte
L’utilità derivante dalle credenze ha un impatto profondo sulla nostra propensione ad acquisire nuove informazioni.
Nel modello neoclassico, una persona razionale non rifiuterebbe mai informazioni gratuite, poiché potrebbero risultare utili anche in futuro.
Chi trae utilità anticipatoria dalle proprie credenze, però, non può ignorare il fatto che certe informazioni potrebbero influenzare il proprio stato emotivo: una volta appresa una notizia spiacevole, è quasi impossibile “disimpararla”.
Un esempio di questa avversione all’informazione riguarda la Malattia di Huntington, una grave patologia neurologica degenerativa che si trasmette geneticamente, con una probabilità del 50% per chi ha un genitore malato.
Attualmente non esiste una cura. Nonostante i possibili vantaggi di conoscere in anticipo il proprio stato (per pianificare la famiglia, la pensione, l’istruzione o partecipare a studi clinici), la ricerca di Oster, Shoulson e Dorsey ha mostrato che pochissime persone a rischio scelgono di sottoporsi a test genetici predittivi.
Spesso, si tende a rimandare l’esame fino a quando non compaiono i primi sintomi, quando però l’informazione ha ormai un valore limitato.
Questo comportamento riflette il desiderio di mantenere una visione ottimistica sul proprio stato di salute e sul futuro.
Il valore pratico delle informazioni, cioè la possibilità di prendere decisioni migliori, si scontra con il costo emotivo di perdere la speranza, ovvero una riduzione dell’utilità anticipatoria.
Chi è a rischio manifesta un ottimismo eccessivo, sottostimando la probabilità di essere malato anche in presenza di segnali evidenti. Questo atteggiamento si traduce in azioni concrete: chi non si sottopone al test o resta nell’incertezza si comporta in modo molto simile a chi ha ricevuto un risultato negativo, evitando di modificare le proprie decisioni su aspetti cruciali come il matrimonio, la pensione anticipata o le scelte riproduttive.
Tutto ciò pone un dilemma etico rilevante: se le persone ottengono benessere dalle loro credenze, trasmettere loro una verità dolorosa può causare grande infelicità.
In questi casi, il "valore della conoscenza" – ossia la possibilità di compiere scelte migliori – deve essere bilanciato con il “valore del benessere psicologico” derivante dal mantenimento di credenze positive.
3. Critiche e punti di forza di un ottimismo eccessivo

«È meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto che pessimisti e avere ragione».
Albert Einstein
L’ottimismo eccessivo, spesso considerato una deviazione dalla razionalità, presenta in realtà un equilibrio complesso di costi e benefici.
Benefici dell’ottimismo eccessivo:
- Benessere psicologico. Numerosi studi mostrano che le “illusioni positive”, come l’eccessiva fiducia in sé stessi, possono sostenere il benessere mentale. Un atteggiamento troppo ottimista può aumentare la felicità, aiutare a gestire feedback negativi e incentivare la creatività e la produttività. Il cosiddetto realismo depressivo suggerisce che aspettative troppo realistiche possano essere dannose per la salute mentale, considerando che la realtà è spesso difficile e imprevedibile. In questo senso, il realismo depressivo rappresenta l’opposto delle illusioni positive: chi ne è soggetto tende a vedere sé stesso e il mondo in modo più oggettivo, ma questa visione, seppur più realistica, è spesso associata a un benessere psicologico inferiore.
- Motivazione. In certi contesti, la fiducia eccessiva (o, talvolta, un’eccessiva modestia) può agire come potente stimolo. Ad esempio, la paura di fallire può spingere a impegnarsi di più, migliorando così i risultati.
Costi dell’ottimismo eccessivo:
- Decisioni errate. Il principale rischio di un ottimismo esagerato è la distorsione del processo decisionale. Ad esempio, credere di essere sempre in salute può portare a trascurare controlli medici o terapie importanti. Nel settore finanziario, l’eccessiva fiducia può spingere trader e investitori verso scelte rischiose e perdite economiche. Anche i manager troppo sicuri di sé tendono a intraprendere più fusioni e acquisizioni, spesso con effetti negativi sul valore delle aziende.
- Potenziale di delusione. Avere aspettative troppo alte espone al rischio di forti delusioni. Quando l’utilità percepita dipende dal confronto con un punto di riferimento, aspettative gonfiate possono alzare troppo l’asticella, rendendo difficile trovare soddisfazione anche in presenza di risultati oggettivamente buoni.
4. Euristiche e bias: quando la mente ci inganna
Oltre all’utilità ricavata dalle credenze, un’altra fonte di deviazione dalle credenze ottimali è rappresentata dalle euristiche e dai bias legati alla complessità del ragionamento bayesiano.
In pratica, il nostro cervello non è un elaboratore perfetto: nella vita quotidiana, molte scelte vengono fatte in condizioni di incertezza, che richiedono stime di probabilità spesso complicate.
Anche se le persone tendono a capire in che direzione aggiornare le proprie convinzioni (ad esempio, dopo una recensione positiva di un film, la probabilità di gradirlo aumenta), sono meno abili a quantificare l’entità di questi aggiornamenti.
Applicare la regola di Bayes è corretto a livello matematico, ma risulta difficile quando le variabili sono numerose o le informazioni ambigue.
Per semplificare, ricorriamo a scorciatoie intuitive (euristiche), che permettono di prendere decisioni rapidamente, evitando la paralisi dell’analisi.
Questi strumenti sono fondamentali per la vita quotidiana, ma generano anche errori sistematici e prevedibili. Tra i bias più noti si trovano:
- Fallacia del giocatore (Gambler's fallacy). Credere che, in una sequenza di eventi indipendenti, un esito che non si è verificato da tempo sia più probabile al prossimo turno. Un esempio è pensare che, dopo molti “rossi” alla roulette, il “nero” sia ormai dovuto, quando in realtà ogni estrazione è indipendente. Questo tipo di errore può influenzare anche decisioni reali, come quelle prese dai giudici nelle richieste di libertà condizionale.
- Fallacia della mano calda (Hot-hand fallacy). La convinzione che una serie di successi, come un giocatore di basket che segna ripetutamente, indichi che sia “in stato di grazia” e che abbia quindi maggiori probabilità di segnare anche i tiri successivi. Sebbene questa idea sia opposta alla fallacia del giocatore, entrambe derivano dall’errata fiducia nella legge dei piccoli numeri: ci si aspetta che anche piccoli campioni riflettano fedelmente le probabilità di lungo periodo.
- Fallacia del tasso di base (Base-rate neglect). Tendenza a trascurare le probabilità di partenza (tassi di base) di un evento, dando troppo peso a nuove informazioni salienti. Ad esempio, davanti a un test HIV con accuratezza del 99%, molti sovrastimano la probabilità di essere malati in caso di test positivo, ignorando che la prevalenza dell’HIV nella popolazione è solo dell’1%. Su 10.000 persone, 100 hanno davvero l’HIV e 9.900 sono sane. Il test individua correttamente 99 malati su 100 (veri positivi), ma per errore segnala come positivi anche l’1% dei sani, cioè 99 persone (falsi positivi). In totale, quindi, risultano positivi 198 individui, ma solo 99 di loro sono effettivamente malati: la probabilità reale di avere la malattia, dopo un test positivo, è dunque circa il 50% e non il 99%. Lo stesso vale anche per l’interpretazione di altri test diagnostici, come quelli per il COVID-19.
- Euristica della rappresentatività. Giudicare la probabilità di un evento sulla base della sua somiglianza con uno stereotipo. Nel celebre “problema di Linda”, le persone ritengono più probabile che Linda sia “cassiera di banca e attiva nel movimento femminista” piuttosto che solo “cassiera di banca”, poiché la descrizione si adatta meglio allo stereotipo. Tuttavia, questa scelta viola una regola fondamentale della probabilità, secondo cui il gruppo più specifico è sempre incluso nel gruppo più generale.
- Euristica della disponibilità. Valutare la probabilità di un evento in base alla facilità con cui vengono richiamati alla mente esempi simili. Ad esempio, gli omicidi sono molto più visibili e raccontati dai media rispetto ai suicidi: per questo motivo, molte persone sono portate a pensare che gli omicidi siano più comuni dei suicidi, quando invece, nella maggior parte dei paesi, i suicidi sono nettamente più numerosi degli omicidi secondo i dati statistici ufficiali.
5. Come le politiche pubbliche possono orientare le scelte collettive e il benessere
Comprendere le diverse ragioni alla base delle convinzioni errate è essenziale per progettare politiche pubbliche efficaci, poiché le soluzioni più adatte variano a seconda del problema.
Attenzione limitata o idee sbagliate sulla realtà
Quando il problema è la scarsa attenzione o una comprensione distorta del mondo, rendere le informazioni più visibili e chiare – ad esempio tramite etichette alimentari ben progettate o avvisi sui rischi del fumo – può aiutare concretamente le persone a compiere scelte migliori.
Utilità derivante dalle credenze (credenze motivate)
Se invece le convinzioni sono mantenute per il benessere psicologico che offrono, cercare di “correggerle” rischia di essere non solo inefficace (le persone potrebbero evitare l’informazione), ma anche problematico dal punto di vista etico, poiché potrebbe ridurre la felicità individuale.
In certi casi, soprattutto quando le conseguenze non sono gravi e l’individuo non può intervenire per cambiare il risultato, lasciare spazio a un’ignoranza auto-indotta può essere la scelta più saggia.
Un esempio può essere la scelta di non voler conoscere il sesso del nascituro durante la gravidanza: in molti casi, l’informazione non modifica le scelte pratiche dei genitori, mentre mantenere la sorpresa può aumentare il piacere e l’emozione dell’attesa.
Bias sistematici dovuti a limiti cognitivi
Se il problema dipende da bias sistematici legati a limiti della mente umana, fornire informazioni corrette e strategie di “debiasing” può migliorare molto la qualità delle decisioni.
Ad esempio, molte persone tendono a lasciarsi influenzare dall’euristica della disponibilità, valutando la probabilità di un evento in base a quanto facilmente ricordano casi simili riportati dai media (come incidenti aerei o vincite al gioco).
Interventi mirati, come la diffusione di statistiche chiare sul reale rischio di determinati eventi, possono aiutare a correggere queste percezioni distorte e portare a scelte più informate.
Conclusioni
Il concetto di utilità derivante dalle credenze, insieme alla comprensione di euristiche e bias, offre una prospettiva più ricca e sfumata sul comportamento umano.
Riconoscere che il benessere dipende non solo da ciò che accade, ma anche da ciò che pensiamo possa accadere o da ciò che crediamo di noi stessi, permette di comprendere meglio fenomeni apparentemente irrazionali e di progettare interventi più efficaci e, soprattutto, più attenti all’aspetto umano.
Negli ultimi anni, la visione sui bias cognitivi si è evoluta: se un tempo venivano considerati solo come fonti di errore e irrazionalità, oggi si riconosce che alcune illusioni ed euristiche possono anche sostenere il benessere, la motivazione e la capacità di affrontare l’incertezza.
L’ottimismo, ad esempio, può migliorare la qualità della vita, così come certe illusioni positive possono essere psicologicamente protettive.
È importante, tuttavia, ricordare che non tutti i bias sono adattivi in ogni contesto: molte euristiche che facilitano le decisioni nella vita quotidiana possono risultare dannose, ad esempio, in ambito finanziario.
Nel mondo degli investimenti, l’eccessiva fiducia, la tendenza a seguire la folla o l’errore nel valutare i rischi possono ancora portare a scelte poco razionali e a significative perdite economiche.
Riconoscere il doppio volto dei bias – come risorsa e come potenziale rischio – è essenziale per comprendere più in profondità il comportamento umano e per progettare interventi più efficaci, sia a livello individuale che collettivo.
La serie di articoli LEZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE contiene:
1. Che cos'è la finanza comportamentale: quando psicologia e finanza convergono
6. Preferenze di rischio 1. Il modello dell'utilità attesa tra teoria e realtà
7. Preferenze di rischio 2. La Prospect Theory (Teoria del prospetto)
8. Preferenze di rischio 3. Perché facciamo certe scelte? La Prospect Theory nella vita quotidiana
9. Preferenze sociali 1. Altruismo, equità e fiducia nelle scelte individuali
12. I limiti dell'attenzione e le loro conseguenze sulle scelte economiche
13. Perché crediamo a ciò che ci fa star meglio: l'utilità derivante dalle credenze
15. Default, nudge e frame: l'architettura delle scelte nelle decisioni finanziarie
16. Malleabilità delle preferenze: dalle scelte inconsapevoli ai nudge nelle politiche pubbliche
17. Povertà e processi cognitivi: gli effetti della scarsità su decisioni e benessere